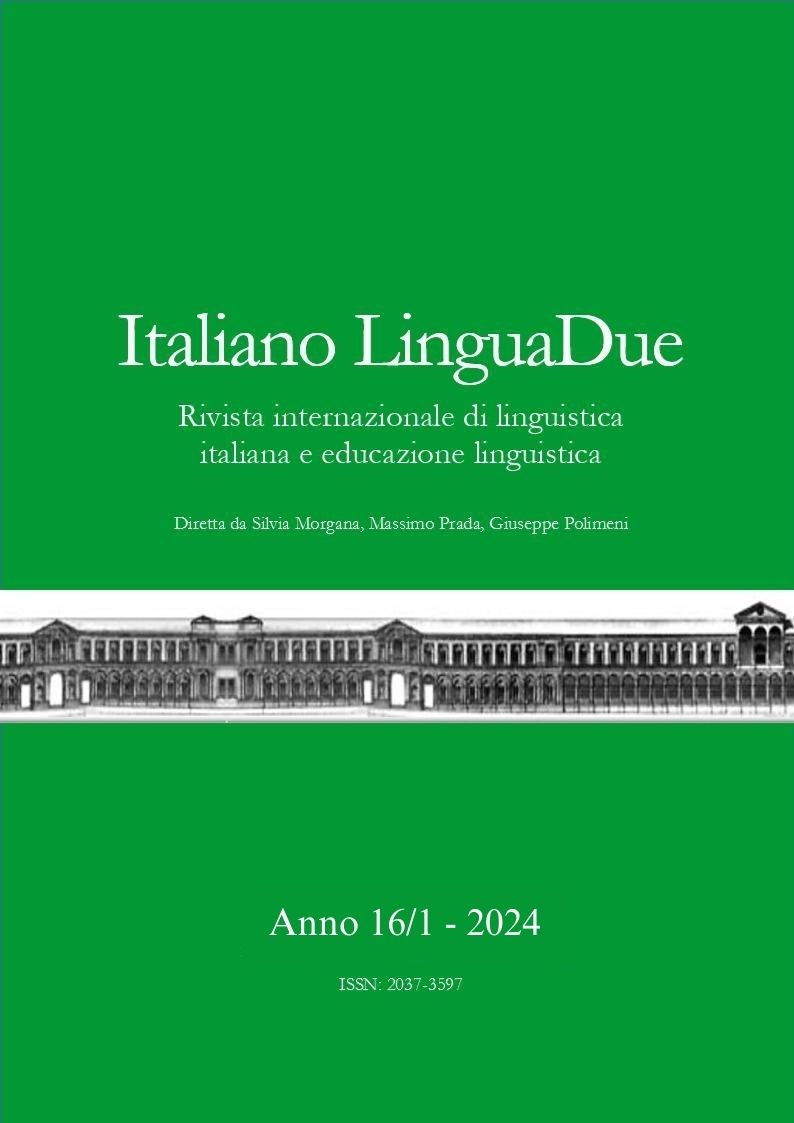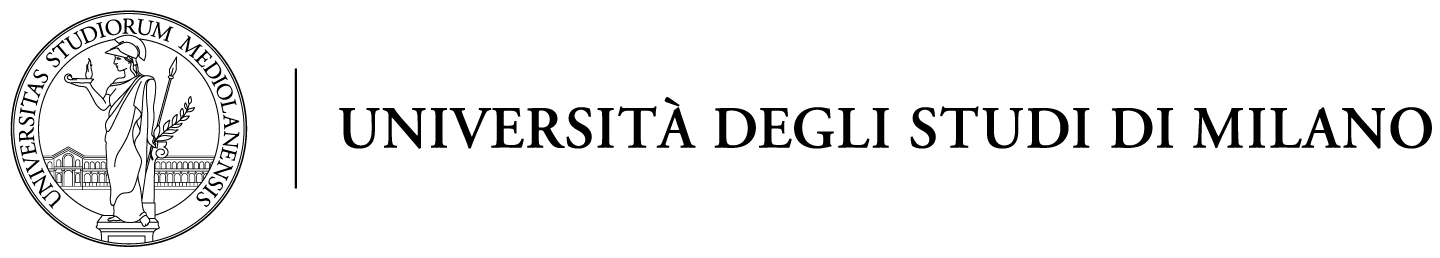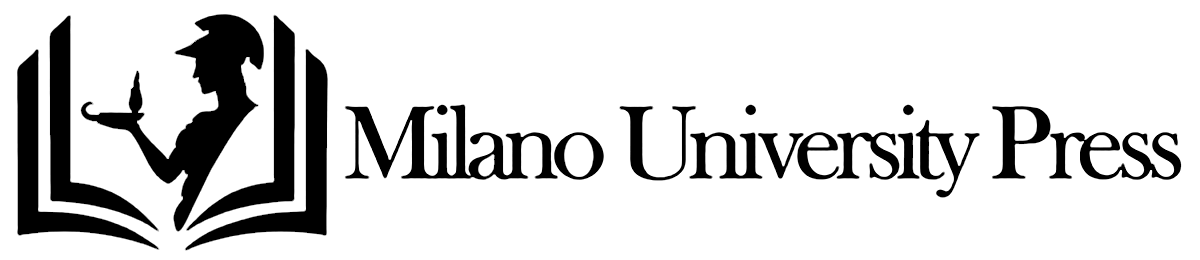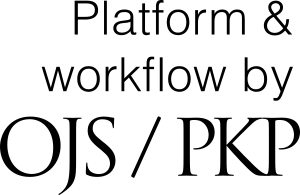INTRODUZIONE
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23788Downloads
Riferimenti bibliografici
Ammon U. (2003), “On the social forces that determine what is standard in a language and on conditions of successful implementation”, in Sociolinguistica, 17, pp. 1-10.
Arntz R., Heribert P., Schmitz K.-D. (2014), Einführung in die Terminologiearbeit, 7a ed., OLMS, Hildesheim.
Bagna C., Barni M. (2007), “La lingua italiana nella comunicazione pubblica/sociale planetaria”, in Studi italiani di linguistica teorica e applicata, XXXVI, 3, pp. 529-553.
Balmford C. (2018), “An ISO Standard for Plain Language: the back story and the next steps”, in Clarity, 79, pp. 6-10.
Beaudet C. (2001), “Clarté, lisibilité, intelligibilité des textes : un état de la question et une proposition pédagogique”, in Recherches en rédaction professionnelle, 1, 1, pp. 1-19.
Beccaria G. L. (2022), In contrattempo. Un elogio della lentezza, Einaudi, Torino.
Bedijs K. (2021), “Schlägt Verständlichkeit Diversität – oder schafft Diversität Verständlichkeit? Zu öglichkeiten und Grenzen gendersensibler Sprache in der Leichten Sprache”, in trans-kom, 14, 1, pp. 145-170: https://www.trans-kom.eu/bd14nr01/trans-kom_14_01_08_Bedijs_Gender.20210517.pdf.
Bertini Malgarini P. (1994), “L’italiano fuori d’Italia”, in Serianni L., Trifone P. (a cura di), Storia della lingua italiana, Einaudi, Torino, 3 voll. (1993-1994), vol. III Le altre lingue, pp. 883-892.
Bertini Malgarini P. (2011), “Mondo, italiano nel”, in Simone R. (a cura di), Enciclopedia dell’italiano, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma:
https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-nel-mondo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/.
Bertuccelli M. (2001), “Le frasi finali”, in Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di), Grande grammatica italiana di consultazione (Vol. 2), Bologna, il Mulino, pp. 818-825.
Bettiol M. (2015), Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura, Marsilio, Venezia.
Bianco F. (2010), “Frasi causali”, in Simone R. (dir.), Enciclopedia dell’Italiano, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma:
https://www.treccani.it/enciclopedia/frasi-causali_(Enciclopedia-dell’Italiano).
Blommaert J., Maly I. (2014), “Ethnographic linguistic landscape analysis and social change: A case study”, in Tilburg Papers in Culture Studies, 100 (s.p.)
Blum-kulka S., House J., Kasper G. (1989), Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies, Ablex, Norwood, New Jersey.
Bombi R. (2014), “Italicità, food e slow food. Una nuova dimensione culturale ed espressiva”, in Bombi R., Orioles V. (a cura di), Essere italiani nel mondo globale oggi: riscoprire l’appartenenza, Forum, Udine, pp. 65 -76.
Bombi R. (2017), “Italianismi migranti. Interferenze linguistiche e storytelling”, in Testi e linguaggi, 11, pp. 157-170.
Bombi R., Orioles V. (2015) (a cura di), Italiani nel mondo. Una Expo permanente della lingua e della cucina italiana, Forum, Udine.
Bonomi I., Coletti V. (2015), L’italiano della musica nel mondo, Accademia della Crusca, Firenze.
Bonvino et al. (2023), Agire in L2. Processi e strumenti nella linguistica educativa, Hoepli, Milano.
Boxer D. (2012), Applying sociolinguistics, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
Brown P., Levinson F. (1987), Politeness. Some Universals in Language Usage, Cambridge University Press, Cambridge.
Caffarelli E. (2016), “I marchionimi italiani e la loro diffusione internazionale”, in D’Achille P., Patota G. (a cura di), L’italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design, Accademia della Crusca – goWare, Firenze, pp. 29-48.
Campanale L. (2022), “Italianità alimentare nella lingua e cultura tedesca: il contributo della gelateria italiana in Germania”, in Italiano LinguaDue, 14, 1, pp. 309-337:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/18182.
Casadei F. (1996), Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico sull’italiano, Bulzoni, Roma.
Cassese S. (1993), “Prefazione”, in Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Libreria dello Stato), Roma, p. 9.
Cheek A. (2010), “Defining plain language”, in Clarity, 64, pp. 5-15.
Chini M. (2011), “Qualche riflessione sulla didattica di L2 ispirata alla recente ricerca acquisizionale”, in Italiano LinguaDue, 2, pp. 1-22:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1912.
Ciccarelli R., Pietrandrea P. (2023), “Per un linguaggio chiaro della comunicazione istituzionale Quale ruolo della linguistica e dei linguisti?” in Piemontese E. (a cura di), Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent’anni dal Codice di stile, Carocci, Roma, pp. 89-105.
Cortelazzo M. A. (2014), “L’italiano nella scrittura amministrativa”, in Lubello S. (a cura di), Lezioni d’italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio, il Mulino, Bologna, pp. 85-104.
Cortelazzo M. A. (2015), “La semplificazione dei testi amministrativi. Le buone pratiche”, in Bombi R. (a cura di), Quale comunicazione tra Stato e cittadino oggi? Per un nuovo manuale di comunicazione, Il Calamo, Roma.
Cortelazzo M. A. (2021), Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione, Carocci, Roma.
Cortelazzo M. A. (2023), “La lingua delle leggi italiane”, in Piemontese E. (a cura di), Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent’anni dal Codice di stile, Carocci, Roma, pp 110-122.
Cortelazzo M. A., Pellegrino F. (2003), Guida alla scrittura istituzionale, Laterza, Roma-Bari.
D’Angelo M. C., Diadori P. (a cura di) (2018), Nella classe di italiano come lingua seconda/straniera. Metodologie e tecnologie didattiche, Franco Cesati Editore, Firenze.
Dahl Ö. (2004), The growth and maintenance of linguistic complexity, John Benjamins, Amsterdam.
Dahl Ö. (2009), “Testing the assumption of complexity invariance: The case of Elfadian and Swedish”, in Sampson G., Gil D., Trudgill P. (eds.), Language complexity as an evolving variable, Oxford University Press, Oxford, pp. 50-63.
De Mauro T. (2016), “Il nuovo Vocabolario di Base”, Internationale:
Delavigne V. (2019), “Littératies en santé et forums de patients : des formes d’ergonomie discursive”, in Éla. Études de Linguistique Appliquée, 195, 3, pp. 363-381.
Della Putta P. (2020), “Difficoltà di adattamento al contesto comunicativo nella scrittura di studenti universitari italofoni e non italofoni. Il ruolo dell’esperienza varietistica nella didattica della L1 e della L2”, in Grassi R. (a cura di), La scrittura e/per l’apprendimento dell’italiano L2, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 209-224.
Deutsches Institut für Normung E.V. (2023), “DIN SPEC 33429 Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache”:
Diewald G., Steinhauer A. (2020), Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich Gendern, Duden, Berlin.
Egger J.-L., Ferrari A., Lala L. (a cura di) (2013), Forme linguistiche dell’ufficialità. L’italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera, Casagrande, Bellinzona.
Ferrari A., Carlevaro A., Evangelista D., Lala L., Marengo T., Pecorari F., Piantanida G., Tonani G. (a cura di) (2024), La comunicazione istituzionale durante la pandemia in Ticino, con uno sguardo ai Grigioni, Casagrande, Bellinzona.
Ferrari A., De Cesare A. M., Evangelista D., Lala L., Marengo T., Pecorari F., Piantanida G., Rosi B. (2022), “Il corpus It-Ist_CH: un corpus rappresentativo dell’italiano istituzionale svizzero”, in Baranzini L., Casoni M., Christopher S. (a cura di), Linguisti in contatto 3. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Bellinzona, pp. 57-70.
Ferrari A., Pecorari F. (in stampa), “La guida al linguaggio inclusivo di genere per i testi della Confederazione Svizzera”, in Lingue e culture dei media.
Ferrari A., Sciumbata F. C. (2023), “Il problema della testualità nella lingua easy-to-read. Ricognizioni e sistemazioni, anche in vista di valutazioni sperimentali”, in Studi italiani di linguistica teorica e applicata, LII, 2, pp. 312-332.
Fiorentino G. (2011), “Scrittura liquida e grammatica essenziale,” in Cardinale U. (a cura di), A scuola d’italiano a 150 anni dall’Unità, il Mulino, Bologna, pp. 219-241.
Fiorentino G. (2020), La lingua nella comunicazione. Corso di linguistica generale, Le Monnier Università, Firenze.
Fioritto A. (a cura di) (1997), Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna.
Fioritto A. (2009), Manuale di stile dei documenti amministrativi, il Mulino, Bologna.
Gałkowski A. (2011), “Dalla Fiat alla Lavazza con una sosta dolce alla Nutella... La conoscenza dei nomi commerciali come elemento della competenza linguistica e interculturale in italiano L2”, in Italica Wratislaviensia, 2, pp. 79-93.
Gałkowski A. (2018), “L’onimia e lo sviluppo della competenza onomastica in italiano L2”, in D’Angelo M. C., Diadori P. (a cura di), Nella classe di italiano come lingua seconda/straniera. Metodologie e tecnologie didattiche, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 109-118.
Gilardoni S. (2020), I nomi commerciali nella didattica dell’italiano L2. Un viaggio nel mondo del design italiano, EDUCatt, Milano.
Gorter D. (2013), “Linguistic Landscapes in a Multilingual World”, in Annual Review of Applied Linguistics, 33, pp. 190-212.
Hawkins J. (2004), Efficiency and Complexity in Grammars, Oxford University Press, Oxford.
House J., Kasper G. (1987), “Interlanguage pragmatics: requesting in a foreign language”, in Lörscher W., Schulze R. (eds.), Perspectives on Language in Performance, 2, Gunter Narr, Tubingen, pp. 1250-1288.
ISO 1087 (2019), Terminology work and terminology science – Vocabulary, International Organization for Standardization, Geneva.
ITTIG, Accademia della Crusca (2011), Guida alla redazione degli atti amministrativi:
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf.
Kövecses Z. (2005), Metaphor in Culture: Universality and Variation, Cambridge University Press, Cambridge.
Kusters W. (2003), Linguistic Complexity, the Influence of Social Change on Verbal Inflection, Ph.D. Dissertation, University of Leiden, LOT, Utrecht.
Kusters W. (2008), “Complexity in linguistic theory, language learning and language change”, in Miestamo M., Sinnemaki K., Karlsson F. (eds.), Language Complexity. Typology, Contact, Change, John Benjamins, Amsterdam, pp. 3-22.
Lakoff G., Johnson M. (1999), Philosophy in the Flesh: the embodied mind and its challenge to Western thought, Basic books, New York.
Lakoff G., Johnson M. (2003[1980]), Metaphors We Live By, The University of Chicago press, Chicago - London (Kövecses, 2005).
Laundry R., Bourhis R. Y. (1997), “Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study”, in Journal of Language and Social Psychology, 16, 1, pp. 23-49.
Lubello S. (2014), Il linguaggio burocratico, Carocci, Roma.
Lubello S. (2015), “Ancora sull’italiano burocratico. Riflessioni sulla base di un corpus recente (2011-2015), in Studi di grammatica italiana, 34, pp. 263-282.
Lubello S. (2018), “L’antilingua gode di buona salute: nuove forme, vecchi vizi”, in Sergio G. (a cura di), Comunicare cittadinanza nell’era digitale Saggi sul linguaggio burocratico 2.0, FrancoAngeli, Milano, pp. 31-43.
Lubello S. (2020), “I percorsi del burocratese: dalla carta al web”, in Visconti J. (a cura di), Parole nostre. Le diverse voci dell’italiano specialistico e settoriale, il Mulino, Bologna, pp. 113-124.
Lubello S. (2022), “Sulla scrittura degli studenti: modelli di lingua e norme in conflitto”, in D’Aguanno D., Fortunato M., Piro R., Tarallo C. (a cura di), Saggi di linguistica e storia della lingua italiana per Rita Librandi, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 135-146.
Lubello S. (2023), “Da Dembsher al Codice di stile e oltre: un bilancio sul linguaggio burocratico”, in Piemontese E. (a cura di), Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent’anni dal Codice di stile, Carocci, Roma, pp. 58-74.
Lucisano P., Piemontese M. E. (1988), “Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana”, in Scuola e città, 39, 3, pp. 110-124.
MAECI (2021), Stati generali della lingua e delle creatività Italiane nel mondo:
Marocchini E., Rapetti F. (2018), “La prospettiva pragmatica in L2”, poster presentato al XVIII Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Università degli Studi di Roma Tre, 22-24 febbraio 2018, Roma.
Miestamo M. (2008), “Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective”, in Miestamo M., Sinnemäki K., Karlsson F. (eds.), Language Complexity. Typology, contact, change, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, pp. 23-41.
Miglietta A. (2015), “L’immigrato, l’italiano e il burocratese”, in Lingue e Linguaggi, 16, pp. 463-483.
Mortara Garavelli B. (2001), Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino.
Nuzzo E. (2007), Imparare a fare cose con le parole. Richieste, proteste, scuse in italiano lingua seconda, Perugia, Guerra Edizioni.
Orletti F. (2000), La conversazione diseguale. Potere e interazione, Carocci, Roma.
Pallotti G. (2017), “Applying the interlanguage approach to language teaching”, in International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 55, 4, pp. 393-412.
Perego E. (2021), “Easy Language in Italy”, in Lindholm C., Vanhatalo U. (eds.). Handbook of Easy Languages in Europe, Frank & Timme, Berlin, pp. 275-303.
Piemontese M. E. (1996), Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata, Tecnodid, Napoli.
Piemontese M. E. (2023a), “Introduzione”, in Ead, 2023, pp. 11-17.
Piemontese M. E. (2023b), Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent’anni dal Codice di stile, Carocci, Roma.
Pompei A., Mereu L., Piunno V. (eds.) (2023), Light Verb Constructions as Complex Verbs: Features, Typology and Function (Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM], 364), De Gruyter Mouton, Berlin.
Raso T. (2005), La scrittura burocratica. La lingua e l’organizzazione del testo, Carocci, Roma.
Rati M. S. (2023), “L’educazione alla riscrittura: un esperimento didattico su un messaggio INPS”, in Mastrantonio D., Salvatore E. (a cura di), Forme, strutture e didattica dell’italiano. Studi per i 60 anni di Massimo Palermo, Edizioni Università per Stranieri di Siena, Siena, pp. 49-59: https://edizioni.unistrasi.it/1277/1716/L%E2%80%99educazione_alla_riscrittura_un_esperimento_didattico_su_un_messaggio_INPS_-_p._49.htm.
Rossi L. (2009), “Assaggi da un dizionario di italianismi nel mondo”, in Speciali Treccani: http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/mondo/rossi.html.
Sciumbata F. C. (2021), “Dall’inclusione alla didattica della scrittura con il linguaggio facile da leggere e da capire per persone con disabilità intellettive”, in Garulli V., Pasetti L., Viale M. (a cura di), Disturbi specifici dell’apprendimento e insegnamento linguistico. La didattica dell’italiano e delle lingue classiche nella scuola secondaria di secondo grado alla prova dell’inclusione, Bononia University Press, Bologna, pp. 129-136.
Sciumbata F. C. (2022a), Manuale dell’italiano facile da leggere e da capire, Franco Cesati Editore, Firenze.
Sciumbata F. C. (2022b), “Il linguaggio facile da leggere e da capire va all’università. Appunti da un corso di scrittura facilitata per il personale dell’Università di Trieste”, in RITT (Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione – International Journal of Translation), 24, pp. 217-233.
Tamaredo I. (2017), “Syntactic complexity and language contact: A corpusbased study of relative clauses in British English and Indian English”, in Alicante Journal of English Studies, 30, pp. 149-182.
Vedovelli M. (2005), “L’italiano nel mondo da lingua straniera a lingua identitaria: il caso ‘freddoccino’”, in Studi italiani di linguistica teorica e applicata, XXXIV, 34, 3, pp. 585-609.
Vellutino D. (2018), L’ italiano istituzionale per la comunicazione pubblica, il Mulino, Bologna.
Wang M., Shen R., Novak D., Pan X. (2009), “The impact of mobile learning on students’ learning behaviours and performance: Report from a large, blended classroom”, in British Journal of Educational Technology, 40, 4, pp. 673-695.
Wilkinson M. D. et al. (2016), “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”, in Sci. Data, 3: doi: 10.1038/sdata.2016.18.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.