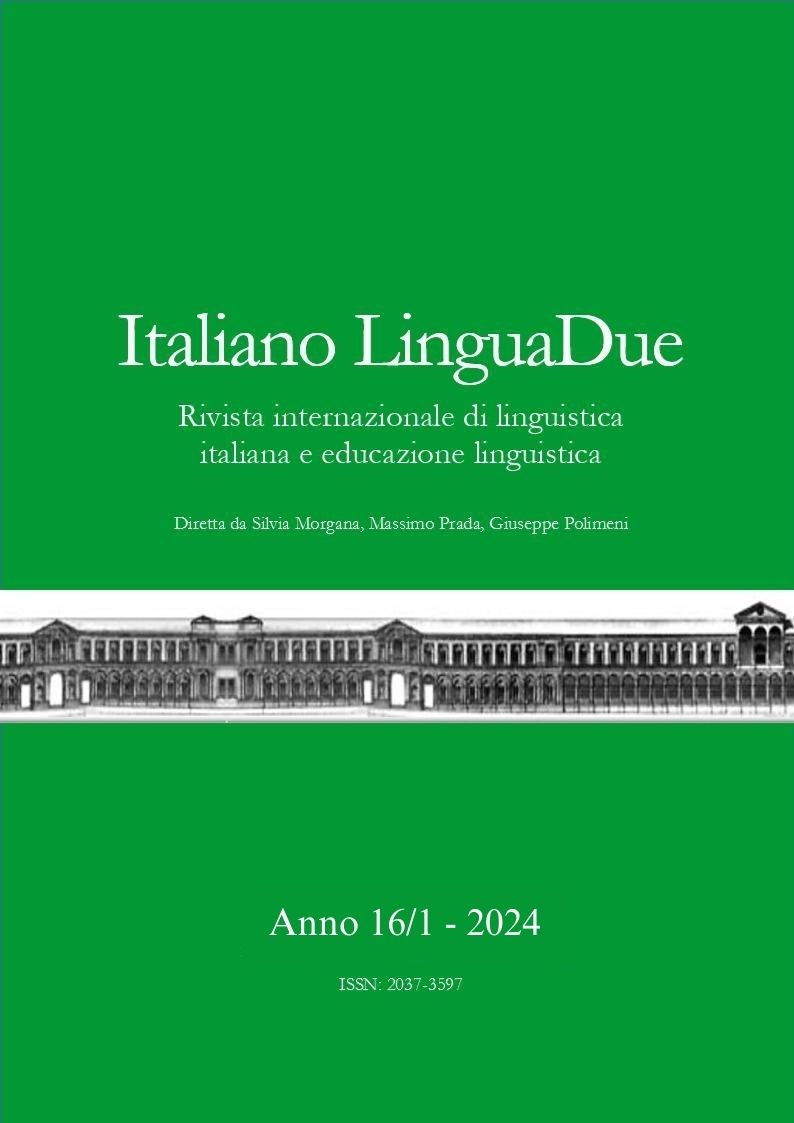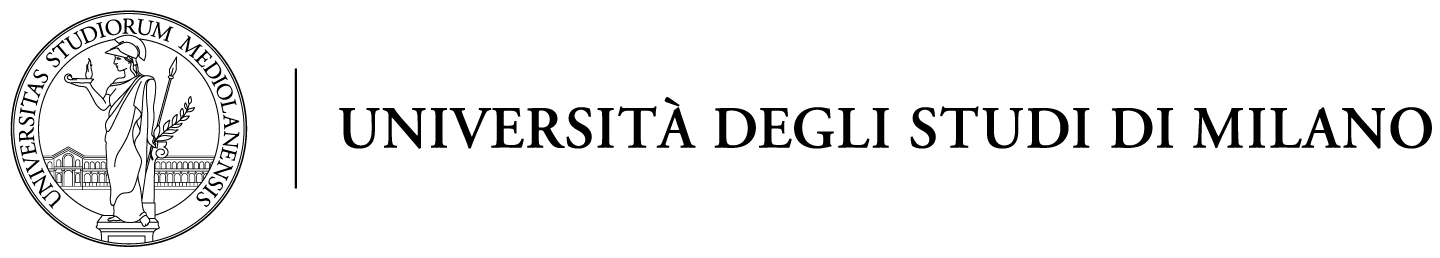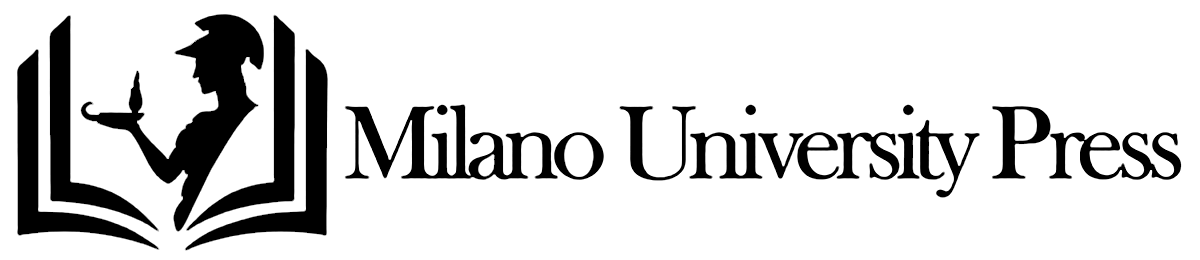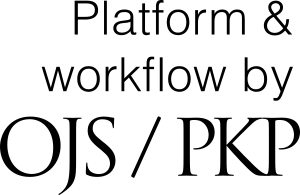UN CICLO GLOTTODIDATTICO INCLUSIVO PER L’ITALIANO COME LINGUA DELLO STUDIO DELLA STORIA
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23851Abstract
Un buon numero di apprendenti non ha maturato consapevolezza sul divario esistente tra la lingua di tutti i giorni, quella usata a casa o tra i pari, e la lingua della scuola e dei materiali scolastici e nemmeno ha consapevolezza del fatto che ciascuna materia scolastica prevede sia l’utilizzo di una lingua specifica che include più dimensioni (lessicale, morfosintattica, testuale, pragmatica…) sia lo svolgimento di operazioni cognitive particolari. Questa mancata percezione è spesso alla base dell’insuccesso scolastico degli apprendenti. Gli insegnanti hanno il compito di guidare la classe nell’acquisizione delle abilità linguistico-cognitive della lingua dello studio della disciplina di insegnamento progettando cicli glottodidattici inclusivi. Stimolare e supportare le fasi di acquisizione della lingua dello studio così come costruire l’accessibilità ai materiali di studio sono interventi didattici fondamentali per ridurre il tasso di insuccesso. In questo contributo si presenteranno le particolarità della lingua dello studio per la storia e verrà illustrato un ciclo glottodidattico inclusivo come modello operativo per l’acquisizione della microlingua storica.
A GLOTTODIDACTIC INCLUSIVE CYCLE FOR ITALIAN AS THE LANGUAGE OF HISTORY STUDY
A good number of learners have not become aware of the gap between everyday language, that used at home or among peers, and the language of school and school materials, nor are they aware of the fact that each school subject involves both the use of a specific language that includes several dimensions (lexical, morphosyntactic, textual, pragmatic...) and the performance of particular cognitive operations. This lack of perception is often at the root of learners’ academic failure. Teachers have the task of guiding the class in the acquisition of the linguistic-cognitive skills of the language of instruction by designing inclusive glottodidactic cycles. Stimulating and supporting the acquisition phases of the language of study as well as building accessibility to study materials are fundamental didactic interventions to reduce the failure rate. This contribution will present the particularities of the study language for history and illustrate an inclusive glottodidactic cycle as an operational model for the acquisition of the historical micro-language
Downloads
Riferimenti bibliografici
Amoruso C. (2010), In parole semplici, La riscrittura funzionale dei testi nella classe plurilingue, Palumbo, Palermo.
Arici M., Cristofori S., Maniotti P. (2006), Apprendere e insegnare la lingua per studiare, IPRASE Trentino, Trento.
Balboni P. E. (2009), Storia dell’Educazione Linguistica in Italia. Dalla legge Casati alla riforma Gelmini, UTET, Torino.
Balboni P. E. (2014), “Introduzione. Il progetto Materiali integrativi Loescher per l’Educazione Linguistica – MILEL”, in Balboni P. E., Mezzadri M. (a cura di), L’italiano L1 come lingua dello studio. Quaderni della ricerca, vol. 15, Loescher, Torino, pp 7-12.
Beacco J.-C., Fleming M., Goullier F., Thurmann E. e Vollmer H. (2016), “Le dimensioni linguistiche di tutte le discipline scolastiche. Una Guida per l’elaborazione dei curricoli e per la formazione degli insegnanti”, Consiglio d’Europa, Unità delle Politiche Linguistiche, Divisione delle politiche educative, Strasbourg, in ItalianoLinguaDue, Vol. 8, n. 1, pp. 1-195:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7579/7352.
Benavente Ferrera S. (2021), “Costruire l’accessibilità al testo disciplinare: una risorsa inclusiva nella classe plurilingue della scuola secondaria di primo grado”, in Educazione interculturale, 19, 2, pp. 176-192.
Blue G. M. (1993), Language, Learning and Success: Studying thorugh English, Developments in ELT, Macmillan, Modern English Teacher e British Council, London.
Bozzone Costa (2003), “Come lavorare sulle caratteristiche linguistiche dei testi disciplinari”, in Grassi R., Valentini A., Bozzone Costa R. (a cura di), L’italiano per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e facilitazione, Guerra, Perugia, pp. 113-135.
British Dyslexia Association (2023), Dyslexia friendly style guide:
Cantani A., Messina R. (2002), Strategie didattiche per alunni bilingui. L’insegnamento dell’italiano tra lingua d’origine e lingua straniera in Francia e in Germania, tesi di master non pubblicata, Master Itals-Università Ca’ Foscari, Venezia.
Caon F. (2008), Educazione linguistica e differenziazione: Gestire eccellenza e difficoltà, UTET, Torino.
Caon F. (a cura di) (2006), Insegnare italiano nelle classi ad abilità differenziate, Guerra, Perugia.
Caon F. (2017), Educazione linguistica nella Classe ad Abilità Differenziate. Teorie di riferimento e quadro metodologico, Bonacci Editore, Torino.
Caon F., Toniolo V. (2016), “La sfida delle classi ad abilità linguistiche differenziate (CAD) in Italia e in Europa”, in Melero Rodríguez C. A. (a cura di), Le lingue in Italia, le lingue in Europa: dove siamo, dove andiamo, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia pp. 137-154.
CAST (2012), Universal Design for Learning Guidelines: http://udlguidelines.cast.org.
CoE (2014) = Consiglio d’Europa, Raccomandazione CM/Rec (2014)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sull’importanza delle competenze nella(e) lingua(e) di scolarizzazione per l’equità e la qualità nell’istruzione e per il successo scolastico, Trad. it. di Lugarini E., in Italiano LinguaDue, 6, 2, pp. 1-18: https://rm.coe.int/16806acc1b.
CoUE (2019) = Consiglio dell’Unione Europea, Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue (2019/C 189/03), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 189:
Coluccio M. (2011), “Insegnamento e apprendimento della storia in una classe plurilingue e multiculturale”, in Italiano LinguaDue, 3, 1, pp. 159-176: https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1232.
Cummins J. (1979), “Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children”, in Review of educational research, 49, 2, pp. 222-251.
Daloiso M. (2012), Lingue straniere e dislessia evolutiva: Teoria e metodologia per una glottodidattica accessibile, UTET, Torino.
Daloiso M. (2013), “Riflessioni sul raggio d’azione della glottodidattica speciale: Una proposta di definizione e classificazione dei ‘Bisogni linguistici specifici’”, in Educazione Linguistica – Language Education EL.LE, 2, 3, pp. 635-649.
Daloiso M. (2015), L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni specifici. Italiano, lingue straniere e lingue classiche, UTET, Torino.
Daloiso M. ( a cura di) (2016), I Bisogni Linguistici Specifici. Inquadramento teorico, intervento clinico e didattica delle lingua, Erickson, Trento.
Daloiso M., Gruppo di Ricerca ELICom (2023), Le difficoltà di apprendimento delle lingue a scuola, Erickson, Trento.
Daloiso M. (2023), “Promuovere l’inclusione nella classe di lingua: dalle procedure didattiche tradizionali al Ciclo Glottodidattico”, in EL.LE, 12, 2, pp. 273-302.
D’Annunzio B., Luise M. C. (2008), Studiare in lingua seconda. Costruire l’accessibilità ai testi disciplinari, Guerra, Perugia.
De Mauro T. (a cura di) (1994), Studi sul trattamento linguistico dell’informazione scientifica, Bulzoni, Roma.
De Mauro T. (2014), “L’italiano per capire e per studiare”, in Colombo A., Pallotti G. (a cura di), L’italiano per capire, Aracne, Roma, pp. 19-28.
Deon V. (1997), “I manuali di storia fra divulgazione, parafrasi e storia generale”, in Calò R., Ferreri S. (a cura di), Il testo fa scuola, La Nuova Italia, Firenze.
Dudley-Evans T., St John M. G. (1998), Developments in English for Specific Purposes, Cambridge University Press, Cambridge.
Favaro G. (a cura di) (1999), Imparare l’italiano. Imparare in italiano, Guerini, Milano.
Giannone C. (2022), “Se leggo e comprendo, allora apprendo. La “riscrittura funzionale” in classe per contrastare la complessità dei manuali scolastici”, in Italiano LinguaDue, 14, 1, pp. 1038-1067: https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/18337.
Giscel (a cura di) (2007), Educazione linguistica democratica. A trent’anni dalle Dieci tesi, FrancoAngeli, Milano.
Grassi R. (2002), “Educazione linguistica nella scuola plurilingue: la microlingua della storia nei libri di testo per la scuola media”, in Linguistica e Filologia, 14, pp. 195-212.
Grassi R., Valentini A., Bozzone Costa R. (a cura di) (2003), L’italiano per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e facilitazione.
Atti del Convegno-Seminario “Alunni stranieri nella scuola: l’italiano per lo studio” (Bergamo, 17-19 giugno 2000), Guerra, Perugia.
Halliday M. A. K. (1999), Language and Education, Bloomsbury, London.
Ireson J., Hallam S. (2001), Ability Grouping in Education, Paul Chapman Publishing, London.
Lo Duca M. G. (2006), Sillabo di italiano L2, Carocci, Roma.
Luise M. C. (2003), “L’italiano per lo studio e per il successo scolastico: la semplificazione dei testi”, in Luise M. C. (a cura di), Italiano Lingua Seconda. Fondamenti e metodi. Coordinate, vol. 1, Guerra, Perugia, pp. 99-120.
Luise M. C. (2014), “La lingua dello studio”, in Balboni P. E., Mezzadri M. (a cura di), L’italiano L1 come lingua dello studio, Quaderni della ricerca, vol. 15, Loescher, Torino, pp 17-34.
Mezzadri M. (2010), Il Quadro comune europeo a disposizione della classe. Un percorso verso l’eccellenza, Guerra, Perugia.
Mezzadri M. (2011), Studiare in italiano. Certificare l’italiano per fini di studio, Mondadori, Milano.
Mezzadri M. (2016), Studiare in italiano all’università. Prospettive e strumenti, Loescher, Torino.
Mezzadri M. (2020), “Insegnare e valutare l’italiano per fini di studio in L1 e L2: percorsi convergenti”, in Italiano LinguaDue, 12,1, pp. 11-25:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13742.
MIUR (2012), Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, in Annali della Pubblica Istruzione, 88:
htpp://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/-Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf.
MIUR (2013), Decreto Ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria.
MPI (2006), Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005-2006: www.istruzione.it.
Nuzzo E., Grassi R. (2015), Input, output e interazione nell’insegnamento delle lingue, Loescher, Torino.
Porcelli G. (1994), Principi di glottodidattica, La Scuola, Brescia.
Şalli-Çopur, D. (2005), “Coping with the Problems of Mixed Ability Classes”, in The Internet TESL Journal, 10, 8:
http://iteslj.org/Techniques/Salli-Copur-MixedAbility.html
Scataglini C. (2017), Facilitare e semplificare libri di testo. Adattare contenuti disciplinari per l’inclusione, Erikson, Trento.
Schleppegrell M. J. (2004), The Language of Schooling. A functional linguistics perspective. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
Thürmann E., Vollmer H., Pieper I. (2012), “Lingua(e) di scolarizzazione e apprendenti vulnerabili”, in Italiano LinguaDue, 4, 2, pp. 131-183:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/2830.
Tice J. (1997), The Mixed Ability Class, Richmond, London.
Turano A. (2021), “Lingua di scolarizzazione, equità e qualità nell’istruzione e successo scolastico. Note a margine della Raccomandazione CM/Rec (2014)5 del Consiglio d’Europa”, in Italiano a scuola, pp. 411-426: https://doi.org/10.6092/issn.2704-8128/13014.
Ur P. (1996), A Course in Language Teaching: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
Vedovelli M. (2010), Guida all’italiano per stranieri. Dal Quadro comune europeo per le lingue alla Sfida salutare, Carocci, Roma.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.