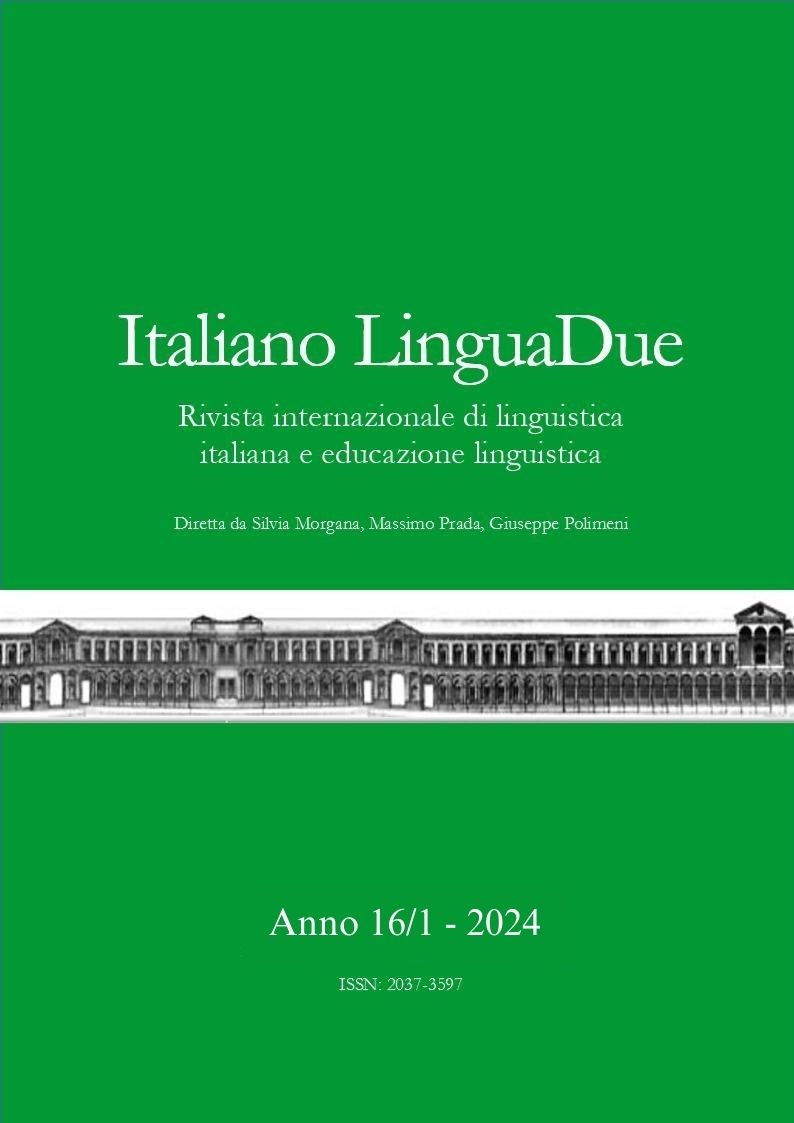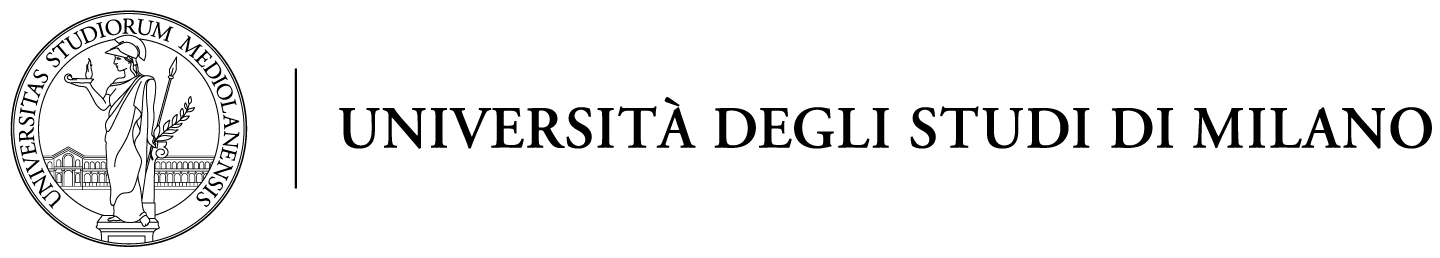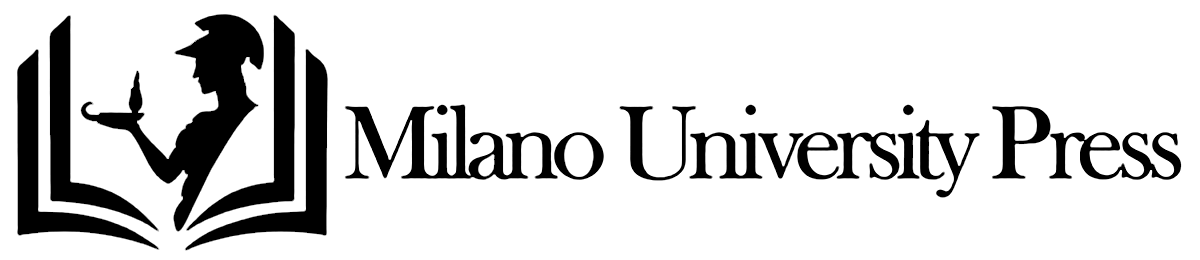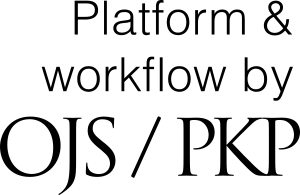SOCIETÀ DIGITALE E SCRITTURA DI MASSA IN ITALIA: ALCUNI PRELIMINARI SOCIOLINGUISTICI
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23881Abstract
Il contributo introduce l’applicazione di nuovi paradigmi di analisi sociolinguistica allo studio della scrittura digitale di massa in Italia. Partendo da una ricognizione dei dati quantitativi inerenti al progressivo radicamento dei nuovi media nella società (con riferimento a dati Censis e Istat), se ne discutono le ripercussioni negli usi della lingua, valutati attraverso le prospettive teoriche del cambiamento sociolinguistico e - in particolare - della mediatizzazione della lingua. La parte conclusiva si concentra sull’importanza dell’evoluzione degli usi della scrittura come codice semiotico nell’era digitale, proponendo alcuni spunti di riflessione afferenti al ramo della sociolinguistica della scrittura.
Digital Society and Mass Writing in Italy: some Sociolinguistic Premises
This paper aims to introduce the application of new sociolinguistic analysis methodologies to the study of mass digital writing in Italy. Starting with a survey of quantitative data concerning the gradual assimilation of new media within society (referring to Censis and Istat data), it highlights the implications on language usage, assessed through the perspectives of sociolinguistic change and, in particular, of mediatization of language. The concluding section focuses the attention on the importance of evolving writing practices in the digital age, proposing some insights within the field of sociolinguistics of writing.
Downloads
Riferimenti bibliografici
Androutsopoulos J. (2006), “Introduction: sociolinguistics and computer mediated communication”, in Journal of Sociolinguistics, 10, 4, pp. 419-438.
Androutsopoulos J. (2011), “Language change and digital media: a review of conception and evidence”, in Standard Languages and Languages Standard in Europe, 1, pp. 145-159.
Androutsopoulos J. (2013), “Online data collection”, in Childs B., Mallinson C., Van Herk G., Data collection in sociolinguistics. Methods and applications, Routledge, New York, pp. 233-244.
Androutsopoulos J. (2014a), “Beyond ‘media influence’ ”, in Journal of Sociolinguistics, 18, 2, pp. 242-249.
Androutsopoulos J. (2014b), “Mediatization and sociolinguistic change. Key concepts, research traditions, open issues”, in Androutsopoulos J. (ed.), Medialization and Sociolinguistic Change, De Gruyter, Berlin-Boston, pp. 3-48.
Androutsopoulos J. (2016), “Thoerizing media, mediation and mediatization”, in Coupland N. (ed.), Sociolinguistics: theoretical debates, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 282-302.
Antonelli G. (2014), “L’e-taliano: una nuova realtà tra le varietà linguistiche italiane?”, in Garavelli E., Soumela-Harma E. (a cura di), Dal manoscritto al Web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua. Atti del XIX congresso SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012), II, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 537-556.
Ballarè S. (2020), “L’italiano neo-standard oggi: stato dell’arte”, in Italiano LinguaDue, 12, 2, pp. 469-492: https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15013.
Ballarè S., Fiorentini I., Miola E. (a cura di) (2024), Le varietà dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma.
Baron N. S. (1998), “Letters by phone or speech by other means: the linguistics of email”, in Language and Communication, 18, pp. 133-170.
Baron N. S. (2008), Always on: language in an Online and Mobile World, Oxford University Press, New York.
Berruto G. (2012 [1987]), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma.
Berruto G. (2017b), “Dinamiche nell’architettura delle varietà dell’italiano nel ventunesimo secolo”, in Caprara G., Marangon G. (a cura di), Italiano e Dintorni. La realtà linguistica italiana: approfondimenti di didattica variazione e traduzione, Lang, Frankfurt at Main, pp. 7-31.
Berruto G. (2018), “Tendenze nell’italiano del Duemila e rapporti fra varietà standard e sub-standard”, in AggiornaMenti, 13, pp. 5-15.
Blommaert J. (2013), “Writing as a sociolinguistic object”, in Journal of Sociolinguistics, 17, 4, pp. 440-459.
Bonomi I., Masini A., Morgana S. (a cura di) (2003), La lingua italiana e i mass media, Carocci, Roma.
Brandt D. (2015), The Rise of Writing. Redefinig Mass Literacy, Cambridge University Press, Cambridge.
Cardona G. R. (1987), Introduzione alla sociolinguistica, Loescher, Torino.
Castellani Polidori O. (1995), La Lingua di Plastica. Vezzi e malvezzi dell’italiano contemporaneo, Morano Editore, Napoli.
Castellani Polidori O. (2002), “Aggiornamenti sulla «lingua di plastica»”, in Studi Linguistici Italiani, XXVIII, 2, pp. 161-196.
CENSIS (2010), Comunicazione e media: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Comunicazione.pdf.
CENSIS (2015), Comunicazione e media: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/8 Comunicazione_e_med ia_2015.pdf .
CENSIS (2018), I media digitali e la fine dello star system:
https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_2.pdf.
CENSIS (2020a), Il capitolo «La Società Italiana al 2020» del 54° rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_la_societ%C3%A0_ italiana_2020.pdf.
CENSIS (2020b), I media e la costruzione delle identità. Sintesi per la stampa: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_27.pdf.
CENSIS (2021a), Il capitolo “La società italiana al 2021” del 55° rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/La%20societaitaliana_2021. pdf.
CENSIS (2021b), I media dopo la pandemia. Sintesi per la stampa:
https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_32.pdf.
CENSIS (2022a), Vivere e valutare la digital life. 2° rapporto sulla connettività in Italia, sintesi dei principali risultati: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/2%C2%B0%20Rapporto% 20Windtre-Censis_Sintesi.pdf.
CENSIS (2022b), I media della crisi: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_31.pdf.
CENSIS (2022c), Il capitolo «La Società Italiana al 2022» del 56° rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico %202022.pdf.
Cesaroni F. M. (2022), “Per uno studio del contatto tra scritto e parlato nei testi di messaggistica istantanea: analisi di un corpus”, in Lingue e Culture dei Media, 6, 1, pp. 68-102.
Coupland N. (2014), “Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media”, in Androutsopoulos J. (ed.), Medialization and Sociolinguistic Change, De Gruyter, Berlin-Boston, pp. 67-96.
Coupland N. (2016), “Five Ms for sociolinguistic change”, in Coupland N. (ed.), Sociolinguistics: theoretical debates, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 433- 454.
Crystal D. (2011), Internet Linguistics, Routledge, London-New York.
D’Achille P. (1990), Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. Analisi dei testi dalle origini al secolo XVIII, Bonacci, Roma.
D’Achille P. (2019 [2003]), L’italiano contemporaneo, il Mulino, Bologna.
D’Onghia L. (2018), “Da quanto tempo gli italiani parlano italiano? Riflessioni sparse sulle questioni dell’italofonia preunitaria”, in Fiorentino G., Ricci C., Siekiera A. (a cura di), Trasversalità delle lingue e dell’analisi linguistica, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 35-48.
De Mauro T. (1997 [1963]), Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari.
De Mauro T. (2014), Storia linguistica dell’Italia repubblicana. Dal 1946 ai nostri giorni, Laterza, Roma-Bari.
Eco U. (1964), Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano.
Ferrari A. (2017), “Tra punteggiatura e testualità. Virgola, punto e punto e virgola nella scrittura mediata dal computer”, in Lingue e Culture dei Media, 1, 2, pp. 1-14.
Fiorentino G. (2004), “Scrivere come si parla. Variabilità diamesica e CMC: il caso dell’e- mail”, in Horizonte, 8, pp. 83-110.
Fiorentino G. (2011), “Informe informale: le amicizie in rete”, in Cerruti M., Corino E., Onesti C. (a cura di), Formale e informale: la variazione di registro nella comunità elettronica, Carocci, Roma, pp. 102-125.
Fiorentino G. (2014), “ ‘Ti auguro tanta fortuna, ma non dov’esse esser così…’ norma liquida tra internet e scrittura accademica”, in Lubello S. (a cura di), Lezioni di italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio, il Mulino, Bologna, pp. 181-204.
Fiorentino G. (2016), “Scrittori per caso: scritture spontanee sul web”, in Lubello S. (a cura di), L’e-italiano. Scriventi e scritture nell’era digitale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 53-72.
Fiorentino G. (2018a), “Sociolinguistica della scrittura: varietà del web nel repertorio linguistico italiano”, in De Santis C., Grandi N., Masini F., Tamburini F. (a cura di), CLUB - Circolo Linguistico dell’Università di Bologna, Bologna, 2, pp. 40-60.
Fiorentino G. (2018b), “Sociolinguistica della scrittura: prospettive e applicazioni”, in Rivista Italiana di Dialettologia, 42, pp. 53-77.
Fornari R. (2020), “Internet in Everyday Life: Profiling Individual Behaviour in the Field of Online Experience”, in DigiCult - Scientific Journal of Digital Cultures, 5, 1, pp. 17- 28.
Giovanardi C. (1993), “Note sul linguaggio dei giovani romani di borgata”, in Studi linguistici italiani, XIX, 62-78.
Gheno V. (2017), “Parlare di dialetto in 140 caratteri: un dialogo tra il profilo Twitter della Crusca e i suoi utenti”, in Marcato G. (a cura di), Dialetto uno nessuno e centomila, CLEUP, Padova, pp. 415-422.
Grandi N., Masini F. (2020), “Perché la linguistica ha bisogno di divulgazione (e viceversa), in Grandi N., Masini F. (a cura di), La linguistica della divulgazione, la divulgazione della linguistica. Atti del IV Convegno Interannuale SLI nuova serie (Bologna, 14-15 giugno 2018), Officinaventuno, Milano, pp. 5-12.
Herring S. (ed) (1996), Computer-Mediated Communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
Hepp A. (2014), “Mediatization. A panorama of media and communication research”, in Androutsopoulos J. (ed.), Medialization and Sociolinguistic Change, De Gruyter, Berlin- Boston, pp. 49-66.
Hepp A., Hjarvard S., Lunby (2015), “Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society”, in Media, Culture & Society, 37, 2, pp. 314-324.
Hjarvard S. (2013), The Mediatization of Culture and Society, Routledge, London. Hudson R. A. (1996 [1980]), Sociolinguistics, Cambridge University Press, New York.
INVALSI (2021), Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2020-2021. I risultati in breve delle prove INVALSI 2021: https://www.invalsiopen.it/risultati/risultati-prove-invalsi- 2021/.
INVALSI (2022), Rapporto Invalsi 2022: https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/Rapporto/R apporto_Prove_INVALSI_2022.pdf.
INVALSI (2023), Rapporto Invalsi 2023:
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Rapporto/R apporto%20Prove%20INVALSI%202023.pdf.
ISTAT (2010), Cittadini e nuove tecnologie: https://www.istat.it/it/files//2011/01/testointegrale201012232.pdf.
ISTAT (2012), L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010: https://www.istat.it/it/archivio/228440; Capp. VII (“Istruzione”) e VIII (“Cultura e tempo libero”).
ISTAT (2015), Cittadini, imprese e ICT: https://www.istat.it/it/files/2015/12/Cittadini- Imprese-e-nuove-tecnologie_2015.pdf.
ISTAT (2019), Cittadini e ICT: https://www.istat.it/it/files//2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf.
ISTAT (2021), Cittadini e competenze digitali: https://www.istat.it/it/files//2023/06/cs-competenzedigitali.pdf.
ISTAT (2022a), Rapporto annuale in pillole: https://www.istat.it/it/archivio/272772.
ISTAT (2022b), I ragazzi e la pandemia: primi risultati dell’indagine sugli alunni delle scuole secondarie: https://www.istat.it/it/archivio/270127.
ISTAT (2022c), Tempo libero e partecipazione culturale: https://www.istat.it/it/files/2022/09/Tempo-libero-e-partecipazione- culturale_Ebook.pdf.
ISTAT 2022d, Lettura di libri e fruizione delle biblioteche: https://www.istat.it/it/files//2023/05/STATISTICA_TODAY_Libri_bibliotech e.pdf.
Jacobs G. E. (2006), “Fast times and digital literacy: partecipation roles and portfolio construction within instant messaging”, in Journal of Literacy Research, 38, 2, pp. 171- 196.
Kress G. (2003), Literacy in the new media age, Routledge, New York.
Labov W. (1994-2001-2010), Principles of Linguistic Change, vol. I “Internal factors”, vol. II “Social Factors”, vol. III “Cognitive and cultural factors”, Wiley-Blackwell, Massachusetts-Oxford.
Lillis T. (2013), The Sociolinguistics of Writing, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Lillis T., McKinney C., (2013), “The sociolinguistics of writing in a global context: objects, lenses, consequences”, in Journal of Sociolinguistics, 17, 4, pp. 415-439. Lo Duca M. G. (2013), Lingua italiana ed educazione linguistica, Carocci, Roma.
Lubello S. (2022), “Sulla scrittura degli studenti: modelli di lingua e norme in conflitto”, in D’Aguanno et al. (a cura di), Saggi di linguistica e storia della lingua italiana per Rita Librandi, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 135-146.
Lubello S. (2023), “Sul ‘parlar scrivendo’. Ancora sulle email degli studenti (universitari)”, in Mastrantonio D., Salvatore E. (a cura di), Forme, strutture e didattica dell’italiano. Studi per i 60 anni di Massimo Palermo, Edizioni Università per Stranieri di Siena, Siena, pp. 345-358.
Marroni S. (2022), La forza della norma, Franco Cesati Editore, Firenze. Mengaldo P. V. (2014 [1994]), Storia dell’italiano nel Novecento, il Mulino, Bologna.
Miola A. (2020), “La divulgazione della linguistica in rete: proposte, problemi, sfide”, in Grandi N., Masini F. (a cura di), La linguistica della divulgazione, la divulgazione della linguistica. Atti del IV Convegno Interannuale SLI nuova serie (Bologna, 14-15 giugno 2018), Officinaventuno, Milano, pp. 15-31.
Nesi A. (a cura di, 2022), L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo, Accademia della
Crusca, Firenze.
OCSE-PISA (2009), Le competenze in lettura, matematica e scienze dei quindicenni italiani. Rapporto Nazionale Pisa 2009:
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/Pisa2009/documenti/RAPPORTO_PISA_2009.pdf.
OCSE-PISA (2015), Indagine Ocse Pisa 2015: i risultati degli studenti italiani in scienze, matematica e lettura: https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2015/doc/rapporto_2015_assemblato.pdf.
OCSE-PISA (2018), Sintesi dei risultati italiani di Ocse Pisa 2018: https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2019/12/Sintesi-dei-risultati- italiani-OCSE-PISA-2018.pdf.
Ong W. J. (1982), Orality and Literacy. The technologizing of the word, Metheun, London-New York.
Palermo M. (2018), “Organizzare il discorso in rete. Caratteristiche della testualità digitale”, in Patota G., Rossi F. (a cura di), L’Italiano e la rete, le reti per l’Italiano, Accademia della Crusca, Firenze, pp. 49-63.
Paolillo J. C. (2001), “Language variation on Internet Relay Chat: a social network approach”, in Journal of Sociolinguistics, 5, 2., pp. 180-213.
Pistolesi E. (2011), “Frammenti di un discorso ordinario. Contributo all’analisi pragmatica degli SMS”, in Held G., Schwarze S. (a cura di), Testi brevi. Teoria e pratica della testualità nell’era multimediale, Bern, Lang, pp. 113-125.
Pistolesi E. (2014), “Scritture digitali”, in Antonelli G., Motolese M., Tomasin L. (a cura di), Storia dell’italiano scritto, vol. III “Lingua d’uso”, Carocci, Roma, pp. 349-375.
Pistolesi E. (2022), L’italiano del web: social network, blog & co, Franco Cesati Editore, Firenze. Pistolesi E. (2018), “L’italiano in rete: usi, varietà e proposte di analisi”, in AggiornaMenti, 13, pp. 17-26.
Prada M. (2015), L’Italiano in rete. Usi e generi della comunicazione mediata tecnicamente, FrancoAngeli, Milano.
Prada M. (2016), “Nuove diamesie: l’italiano dell’uso e i nuovi media (con un caso di studio della risalita dei clitici con bisognare”), in Italiano LinguaDue, 8, 2, pp. 192-219: https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8503.
Regis R. (2019), “Varianti per iscritto. Tendenza di ristandardizzazione ortografica nell’italiano contemporaneo”, in Moretti B., Kunz A., Natale S., Krakenberger E. (a cura di), Le tendenze dell’italiano contemporaneo rivisitate. Atti del LII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Berna, 6-8 settembre 2018), Officinaventuno, Milano, pp. 343-361.
Renzi L. (2000), “Le tendenze dell’italiano contemporaneo. Note sul cambiamento linguistico nel breve periodo”, in Studi di lessicografia italiana, XVII, pp. 279-319.
Renzi L. (2003), “Il cambiamento linguistico nell’italiano contemporaneo”, in Maraschio N., Poggi Salani T. (a cura di), Italia linguistica anno Mille Italia linguistica anno Duemila. Atti del XXXIV convegno della Società di Linguistica Italiana, Bulzoni, Roma, pp. 37-52.
Renzi L. (2012), Come cambia la lingua. L’italiano in movimento, il Mulino, Bologna.
Renzi L. (2019), “Ancora su come cambia la lingua. Qualche nuova indicazione”, in Moretti B., Kunz A., Natale S., Krakenberger E. (a cura di), Le tendenze dell’italiano contemporaneo rivisitate. Atti del LII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Berna, 6-8 settembre 2018), Officinaventuno, Milano, pp. 13- 33.
Sabatini F. (1984), “L’‘italiano dell’uso medio’: una realtà tra le varietà linguistiche italiane”, in Holtus G., Radtke E. (eds.), Umgangssprache in der Iberoromania, Tubingen, Narr, pp. 154-184.
Serianni L. (2006), Prima lezione di grammatica, Laterza, Roma-Bari.
Serianni L. (2014), “Giusto e sbagliato: dove comincia il territorio dell’errore?”, in Lubello S. (a cura di), Lezioni d’italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio, il Mulino, Bologna, pp. 235-246.
Simone R. (2012), Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano.
Simonetti G. (2018), La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, il Mulino, Bologna.
Sobrero A. (a cura di) (1993), Introduzione all’Italiano Contemporaneo, 2 voll., Laterza, Roma- Bari.
Solimine G. (2019), “La lettura e il suo contesto: i dati analizzati con il grandangolo”, in AIB Studi, 58, 3, pp. 427-437.
Solimine G., Zanchini G. (2020), La cultura orizzontale, Laterza, Roma-Bari.
Spina S. (2018), Fiumi di parole. Discorso e grammatica delle conversazioni scritte in Twitter, Aracne, Roma.
Stark E., Ueberwasser S. (2017), “What’s up, Switzerland? A corpus-based research project in a multilingual country”, in Linguistik Online, 84, 5, pp. 105-126.
Tavosanis M. (2011), L’italiano nel web, Carocci, Roma.
Tavosanis M. (2019), “Il rapporto tra le tecnologie, il cambiamento linguistico e l’educazione linguistica”, in Coppola D. (a cura di), Educazione linguistica e insegnamento, Edizioni ETS, Pisa, pp. 97-112.
Voghera M. (2017), Dal parlato alla grammatica. Costruzione e forma dei testi spontanei, Carocci, Roma.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Fabio Massimo Cesaroni

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.