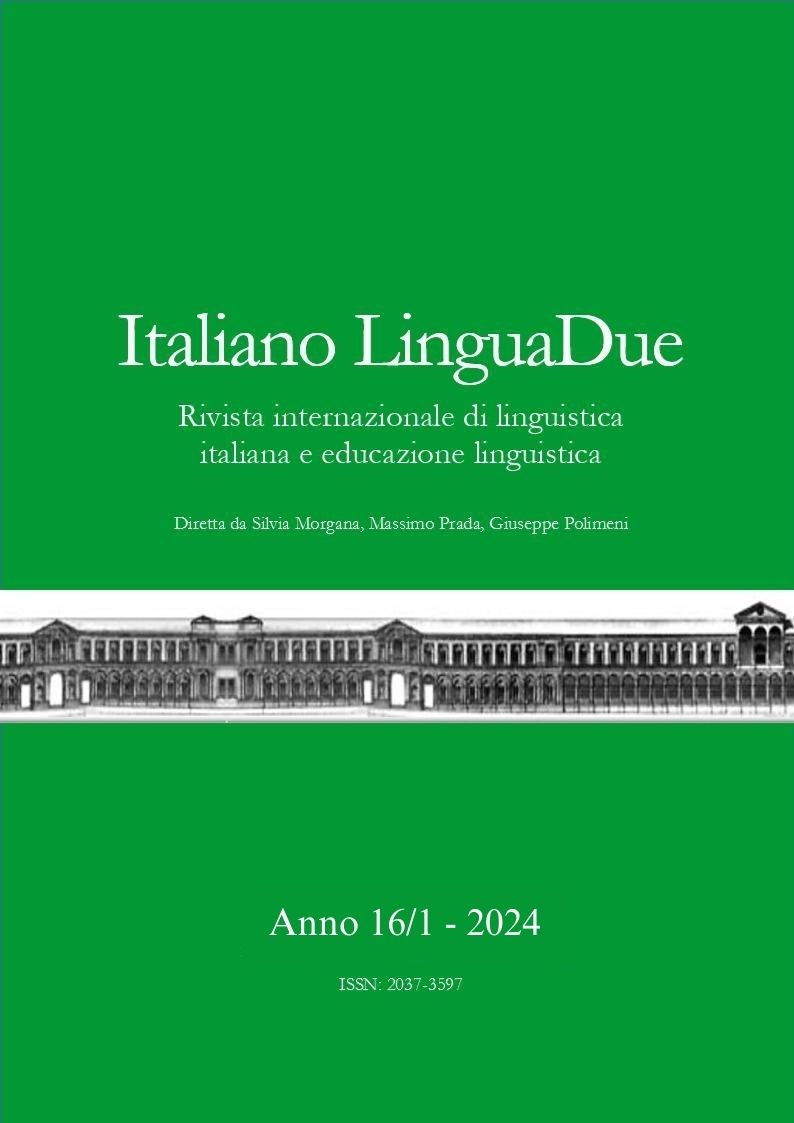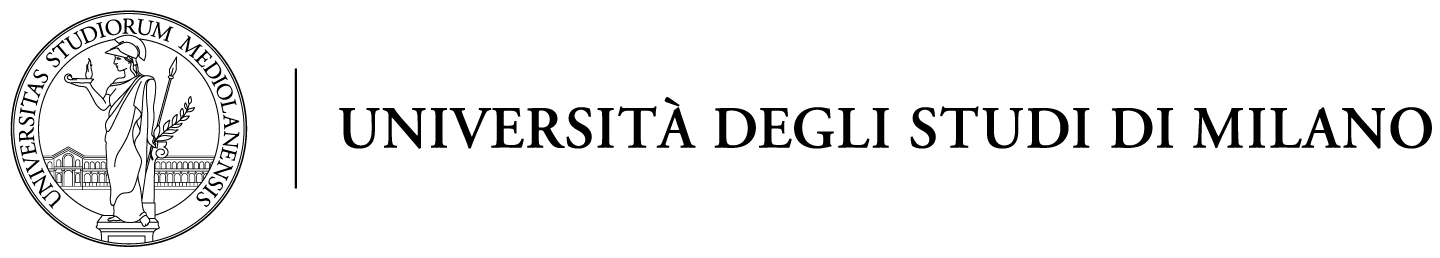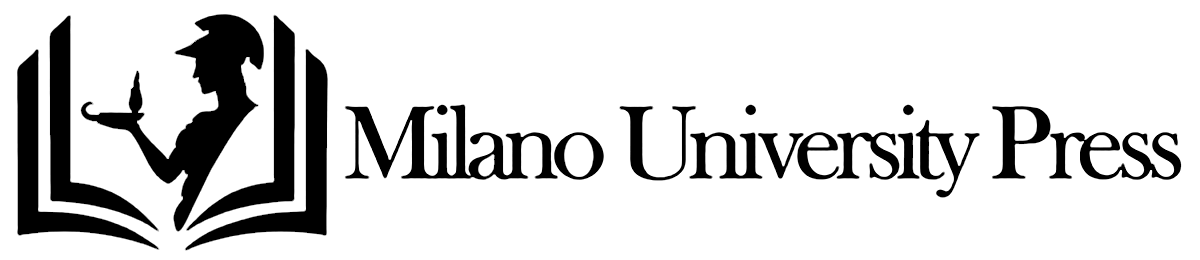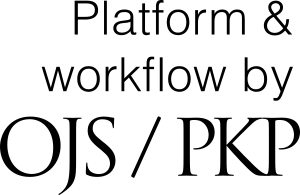PROPOSTE PER UNA LETTURA LINGUISTICA DEL PETRARCHISMO FEMMINILE DEL XVI SECOLO: PRIMI SONDAGGI SU VERONICA GAMBARA, VITTORIA COLONNA E GASPARA STAMPA
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23888Abstract
Finora la critica letteraria, specie negli ultimi anni, ha dedicato sempre maggiore attenzione alle petrarchiste del Cinquecento, in particolar modo soffermandosi sulle vicende personali delle poetesse, sulle tematiche, sull’intertestualità, con occasionali osservazioni stilistiche, mentre mancano ad oggi studi specifici sulla lingua di questa importante produzione lirica. Il contributo offre i primi risultati tendenziali di un ampio studio in corso, che si propone di colmare questa lacuna negli studi linguistici sul Cinquecento. Si presentano qui i risultati di una prima ricognizione linguistica, condotta sui componimenti poetici di Veronica Gambara, Vittoria Colonna e Gaspara Stampa. In particolare, si indagano il lessico e la fraseologia al fine di valutarne la composizione e di verificare elementi di discontinuità ed eventuali novità rispetto al modello petrarchesco e alla tradizione poetica precedente.
Proposals for a linguistic reading of 16th-century female Petrarchism: initial surveys of Veronica Gambara, Vittoria Colonna, and Gaspara Stampa
Literary criticism, especially in recent years, has devoted increasing attention to women petrarchists of the sixteenth century, especially dwelling on the personal histories of the poets, themes, and intertextuality, with occasional stylistic observations, while specific studies on the language of this important lyric production are still lacking. The contribution offers the first tentative results of a large ongoing study, which aims to fill this gap in linguistic studies on the sixteenth century. The results of an initial linguistic reconnaissance, conducted on the poetic compositions of Veronica Gambara, Vittoria Colonna and Gaspara Stampa, are presented here. In particular, the lexicon and phraseology are investigated to assess their composition and to verify elements of discontinuity and possible novelty with respect to the Petrarchan model and the earlier poetic tradition.
Downloads
Riferimenti bibliografici
STUDI SU VERONICA GAMBARA
Andreani V. (2022), “Gambara, Veronica”, in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, vol. III, Salerno, Roma, pp. 239-249.
Bianchi S. (2018), “Le rime e le lettere di Veronica Gambara e l’edizione bresciana del 1759”, in Critica letteraria, XLVI, III, 180, pp. 423-448.
Bozzetti C., Gibellini P., Sandal E. (a cura di) (1989), Veronica Gambara e la poesia del suo tempo nell’Italia settentrionale. Atti del Convegno (Brescia-Correggio, 17-19 ottobre 1985), Olschki, Firenze.
Chimenti A. (1994), Veronica Gambara. Gentildonna del rinascimento: un intreccio di poesia e storia, Magis Books, Reggio Emilia.
Colella M. (2022), “«Cantin le ninfe co’ soavi accenti». Per una definizione del petrarchismo di Veronica Gambara”, in Testo. Studi di teoria e storia della letteratura e della critica, 84, XLIII, 2, pp. 7-36.
Crivelli T. (2008), “L’immagine di sé negli occhi dell’amato: per una lettura del canzoniere di Veronica Gambara”, in ‘Pigliare la golpe e il leone’. Studi rinascimentali in onore di J. J. Marchand, Salerno, Roma, pp. 203-223.
Fortini L. (2014), “Veronica Gambara”, in Liriche del Cinquecento, Iacobelli, Roma, pp. 25-62.
Fortini L. (2016), “Veronica Gambara o del corrispondersi in prosa e in versi”, in Fortini L., Izzi G., Ranieri C. (a cura di), Scrivere lettere nel Cinquecento. Corrispondenze in prosa e in versi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pp. 73-93.
Fortini L. (2021), “Veronica Gambara e il modello canzoniere”, in Letteratura italiana antica: rivista annuale di testi e studi, XXI, pp. 533-535.
Pizzagalli D. (2004), La signora della poesia. Vita e passioni di Veronica Gambara, artista del Rinascimento, Rizzoli, Milano.
STUDI SU VITTORIA COLONNA
Adler S.M. (2021), The poetic power of Vittoria Colonna’s Grief, in Letteratura italiana antica, XXII, pp. 525-531.
Amaduri A. (2018), “«Ch’è Dio vero uomo e l’uomo è vero Dio». Il riscatto femminile nel rapporto con la divinità: ipotesi di lettura intorno alle ‘Rime’ di Vittoria Colonna”, in Battistini L., Caputo V., De Blasi M., Liberti G. A., Palomba P., Panarella V., Stabile A. (a cura di), La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), Adi editore, Roma: https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/la-letteratura-italiana-e-le-arti/Amaduri_Colonna.pdf.
Copello V. (2014), “«Con quel picciol mio sol, ch’ancor mi luce». Il petrarchismo spirituale di Vittoria Colonna”, in Danzi M. (a cura di), Lettura e edizione di testi italiani (secc. XIII-XX). Dieci progetti di dottorato di ricerca all’Università di Ginevra, Pensa Multimedia, Lecce.
Copello V. (2017), “Nuove fonti (e prospettive) per Vittoria Colonna”, in Alfonzetti B., Cancro T., Di Iasio V., Pietrobon E. (a cura di), L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), Adi editore, Roma.
Copello V. (2020), “Per un commento alle rime spirituali di Vittoria Colonna: considerazioni a partire dal sonetto S1:52”, in Schifanoia, 58-59, pp. 175-181.
Crivelli T. (2013), “«Mentre al principio il fin non corrisponde». Note sul Canzoniere di Vittoria Colonna”, in Calligaro S., Di Dio A. (a cura di), M. Praloran 1955-2011 – Studi offerti dai colleghi delle università svizzere, Edizioni ETS, Pisa.
Ferretti F. (2021), “Artemisia sulla soglia”, in Letteratura italiana antica, XXII, pp. 521-524.
STUDI SU GASPARA STAMPA
AA.VV. (2023), «Nova salamandra al mondo»: studi per il centenario di Gaspara Stampa, numero monografico di Rivista di letteratura italiana, XLI, 3.
Amaduri A. (2015), Gaspara Stampa, Bonanno, Acireale-Roma.
Andreani V. (2010), “Tra pseudonimo e senhal. L’onomastica dell’amore nelle Rime di Gaspara Stampa”, in Il nome nel testo, XII, pp. 279-288.
Andreani V. (2017a), “Sul petrarchismo di Gaspara Stampa: il modello di Pietro Bembo”, in Alfonzetti B., Cancro T., Di Iasio V., Pietrobon E. (a cura di), L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), Adi editore, Roma:
Andreani V. (2017b), “Paratesto e macrostruttura nelle “Rime”di Gaspara Stampa”, in Ellero M.P., Residori M., Rossi M., Torre A. (a cura di), Il dialogo creativo. Studi per Lina Bolzoni, Pacini Fazzi, Lucca, pp. 187-198.
Andreani V. (2020), “Commentare le “Rime” di Gaspara Stampa: sulle tracce di un canzoniere”, in Schifanoia, 58-59, pp. 233-239”
Andreani V. (2023a), “I sonetti iniziali delle “Rime” di Gaspara Stampa: modelli, fonti e intenti programmatici”, in Rivista della letteratura italiana, vol. XLI, 3, pp. 19-31.
Andreani V. (2023b), “Le «meste rime» di Gaspara Stampa tra petrarchismo ed elegia”, in Pandemos, 1 (2023):
https://ojs.unica.it/index.php/pandemos/article/view/6025/5778.
Bianchi S. (2013), La scrittura poetica femminile nel Cinquecento veneto: Gaspara Stampa e Veronica Franco, Vecchiarelli, Manziana.
Farnetti M. (2017), Dolceridente. La scoperta di Gaspara Stampa, Moretti & Vitali, Bergamo.
Forni G. (2020), “Tra mito e testo: qualche considerazione sui commenti alle Rime di Isabella di Morra, in Schifanoia, 58-59, pp. 199-205.
Forni G. (2021), “Il sonetto proemiale delle Rime di Gaspara Stampa”, in Letteratura italiana antica, XXII, pp. 541-543.
Forni G. (2023), “Emozione, fede e gelosia nelle «Rime» di Gaspara Stampa”, in Pandemos, 1: https://ojs.unica.it/index.php/pandemos/article/view/6026/5779.
Laurenti G. (2020), “La poetica dell’«interno affetto»: riflessioni sul sonetto CCCV per un discorso sui sonetti religiosi di Gaspara Stampa”, in Schifanoia, 58-59, pp. 249-254.
Russo L. (1958), “Gaspara Stampa e il petrarchismo del ’500”, in Belfagor, 13, 1, pp. 1-20.
Simonato E. (2020), “Come leggere la princeps delle Rime di Gaspara Stampa”, in Schifanoia, 58-59, pp. 241-248.
Tarsi M.C. (2012), “«S’arresti al suon di mia stanca favella». Gaspara Stampa e la parola poetica”, in Filologia e critica, 2, pp. 212-234.
EDIZIONI DI RIFERIMENTO
Bembo P. (2001), Prose della volgar lingua. L’editio princeps del 1525 riscontrata con l’autografo Vaticano latino 3210, edizione critica a cura di Vela C., CLUEB, Bologna.
Bianchi L. (2022), Per un’edizione delle Rime di Vittoria Colonna secondo l’editio princeps del 1538, Tesi di dottorato di ricerca presentata alla Faculty of Arts and Social Sciences dell’Università di Zurigo.
Caro A. (1912), Opere, a cura di Turri V., Laterza, Bari.
Colonna V. (1840), Rime, a cura di Pietro Ercole Visconti, Salviucci, Roma.
Colonna V. (1982), Rime, a cura di Alan Bullock, Laterza, Roma.
Gambara V. (1995), Le rime, edizione critica a cura di Bullock A., Olschki, Firenze.
Petrarca F. (1996), Canzoniere, a cura di Santagata M., Mondadori, Milano.
Scaramuccia F. (2012), Edizione critica delle «Rime» di Gaspara Stampa, Tesi del dottorato di ricerca internazionale in italianistica, ciclo XXIV, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Italianistica (in corso di stampa).
Stampa G. (2010), The complete poems. The 1554 Edition of the “Rime”, a Bilingual Edition, a cura di Tower T. e Tylus J., The University of Chicago Press, Chicago.
STUDI SU PETRARCA E SUL PETRARCHISMO
Afribo A. (2009), Petrarca e petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Carocci, Roma.
Alonso D. (1959), “La poesia del Petrarca e il Petrarchismo (Mondo estetico della pluralità)”, in Lettere italiane, XI, 3, Olschki, Firenze, pp. 277-319.
Baldacci L. (1974 [1957]), Il petrarchismo italiano nel Cinquecento, Liviana, Padova.
Baldacci L. (a cura di) (1975 [1957]), Lirici del Cinquecento, Longanesi, Milano.
Borsetto L. (1983), “Narciso ed Eco. Figura e scrittura nella lirica femminile del Cinquecento: esemplificazioni ed appunti”, in Baradel V., Zancan M. (a cura di), Nel cerchio della luna: figure di donna in alcuni testi del XVI secolo, Marsilio, Vicenza, pp. 171-233.
Calitti F., Chines L., Gigliucci R. (a cura di) (2006), Il petrarchismo. Un modello di poesia per l’Europa, 2 voll., Bulzoni, Roma.
Cella R. (2023), La lingua di Petrarca, il Mulino, Bologna.
Cox V. (2006), “Attraverso lo specchio: le petrarchiste del Cinquecento e l’eredità di Laura”, in Petrarca. Canoni, esemplarità, a cura di Finucci V., Bulzoni, Roma.
Cox V. (2008), Women’s Writing in Italy (1400-1630), Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Crivelli T., Nicoli G., Santi M. (a cura di) (2005), «L’una et l’altra chiave». Figure e momenti del petrarchismo femminile europeo, Atti del convegno internazionale (Zurigo, 4-5 giugno 2004), Salerno, Roma.
Dionisotti C. (1967), “La letteratura italiana nell’età del Concilio di Trento”, in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino, pp. 227-254.
Erspamer F. (1987), “Centoni e petrarchismo nel Cinquecento”, in Mazzacurati G., Plaisance M. (a cura di), Scritture di scritture: testi, generi, modelli nel Rinascimento, Bulzoni, Roma, pp. 463-495.
Farnetti M. (2014), “Poetriarum octo fragmenta. Introduzione”, in Farnetti M., Fortini L., (a cura di), Liriche del Cinquecento, Iacobelli, Roma, pp. 9-23.
Farnetti M. (2020), “Commentare le petrarchiste. Premessa agli Atti del convegno”, in Schifanoia, 58-59, pp. 165-167.
Fedi R. (1990), La memoria della poesia: canzonieri, lirici e libri di rime nel Rinascimento, Salerno, Roma.
Ferroni G. (a cura di) (1978), Poesia italiana del Cinquecento, Garzanti, Milano.
Forni G. (2004), “Lirica femminile”, in Anselmi G.M., Elam K., Forni G., Monda D. (a cura di), Lirici europei del Cinquecento, Rizzoli, Milano, pp. 277-338.
Forni G. (2011), Pluralità del petrarchismo, Pacini, Pisa.
Forni G. (2019), “Lirica e ironia nella poesia femminile del Rinascimento”, in Peloro, IV, 2, pp. 53-87.
Picone M. (2005), “Petrarchiste del Cinquecento”, in Crivelli T., Nicoli G., Santi M. (a cura di), «L’una et l’altra chiave». Figure e momenti del petrarchismo femminile europeo. Atti del Convegno internazionale di Zurigo (4-5 giugno 2004), Salerno, Roma, pp. 17-30.
Quondam A. (1974), Petrarchismo mediato. Per una critica della forma “antologica”, Bulzoni, Roma.
Spagnoletti G. (1959), Il Petrarchismo, Garzanti, Milano.
Tarsi M. C. (2018a), Studi sulla poesia femminile del Cinquecento, Emil, Bologna.
Tarsi M. C. (2018b), “Un’antologia al femminile: le Rime diverse d’alcune nobilissime… donne (1559)”, in Ead., Studi sulla poesia femminile del Cinquecento, Emil di Odoya, Bologna, pp. 179-205.
Toffanin G. (1938), “Petrarchiste del ’500”, in Annali della cattedra petrarchesca, VIII, pp. 145-149.
Vitale M. (1996), La lingua del Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di Francesco Petrarca, Editrice Antenore, Padova.
STUDI DI RIFERIMENTO GENERALE
Tavoni M. (1992), Il Quattrocento, il Mulino, Bologna.
Trovato P. (2012 [1994]), Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Edizioni libreriauniversitaria.it, Padova.
FONTI LESSICOGRAFICHE
GDLI = Salvatore Battaglia (fondato da), Grande Dizionario della Lingua Italiana, 21 voll. (+ 2 supplementi), UTET, Torino, 1961-2009: www.gdli.it.
TLIO = Tesoro della lingua italiana delle Origini, diretto da P. Squillacioti: www.tlio.ovi.cnr.it.
BibIt = Biblioteca italiana: biblioteca digitale di testi: www.bibliotecaitaliana.it.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Stephanie Cerruto

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.