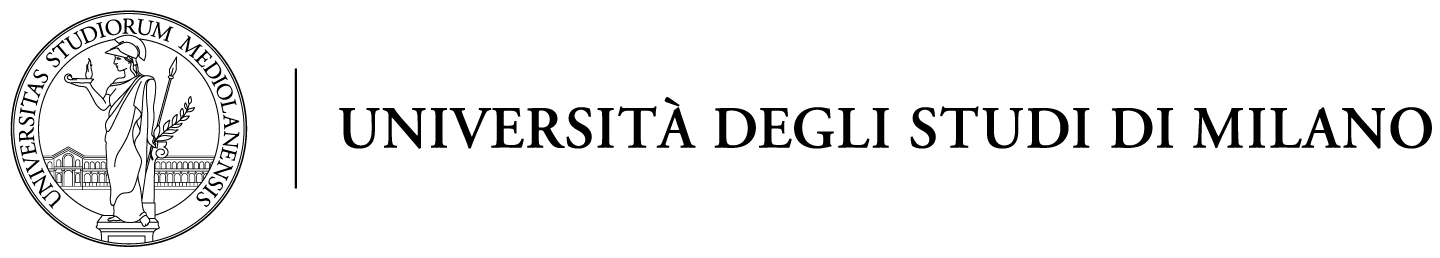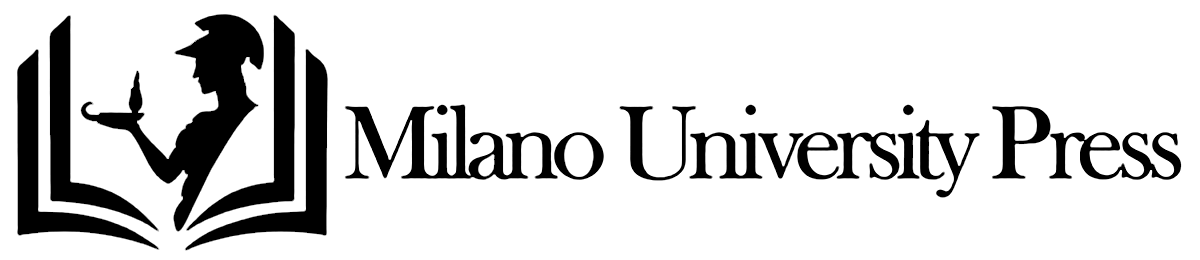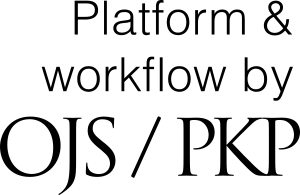TRACCE DI ITALIANO POPOLARE NEL PARLATO CONTEMPORANEO
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/27874Abstract
Nell’ambito degli studi sull’italiano popolare, poca attenzione è stata dedicata alla sua dimensione orale. In questo lavoro vengono presentati i risultati di uno studio basato sul corpus ParlaTO, al fine di verificare se l’italiano popolare sia presente, come varietà parlata, nell’architettura variazionale dell’italiano contemporaneo. L’analisi si fonda sull’osservazione di un insieme di tratti considerati diagnostici, attinti alla letteratura precedente sull’italiano popolare, integrato con alcune nuove proposte. I fenomeni linguistici (di cui si considereranno frequenza, cooccorrenza e peso nelle descrizioni delle diverse varietà) saranno messi in relazione a diversi parametri socioculturali (età, grado di istruzione, professione). L’analisi dei dati offrirà uno spunto di riflessione su uno degli interrogativi più attuali circa l’italiano popolare: se e in che misura, oggi, esso sia una varietà vitale.
Traces of popular italian in contemporary speech
Within the framework of the research on popular Italian, little attention has been paid to its oral dimension. This paper presents the results of a corpus-based research, which aims to verify whether popular Italian is present, as a spoken variety, in the variational architecture of contemporary Italian. The analysis is based on the ParlaTO corpus and considers a set of phenomena as diagnostic traits of IP. Such traits will be related to various socio-cultural parameters (age, education, profession). The data analysis will shed some light on one of the most debated problems about popular Italian: whether, nowadays, it is still a vital language variety.
Downloads
Riferimenti bibliografici
Antonelli G. (2012), “Si parla italiano: si scrive e-taliano?”, in Di Pretorio P. A., Unfer Lukoschik R. (a cura di), Lingua e letteratura italiana 150 anni dopo l’Unità, Martin Meidenbauer, München, pp. 83-91.
Antonelli G. (2014), “L’e-taliano: una nuova realtà tra le varietà linguistiche italiane?”, in Garavelli E., Suomela-Harma E. (a cura di), Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano, Franco Cesati Editore, Firenze, Vol. II, pp. 537-556.
Ballarè S., Micheli S. (2018), “Usi di dove nell’italiano contemporaneo: costruzioni relative e dinamiche di ristandardizzazione”, in Linguistica e filologia, 38, pp. 29-56.
Berruto G. (1983), “L’italiano popolare e la semplificazione linguistica”, in Vox Romanica, 42, pp. 38-79.
Berruto G. (1987), “Lingua, dialetto, diglossia, dilalia”, in Günter H., Kramer J. (a cura di), Romania et Slavia Adriatica. Festschrift für Žarko Muljačić, Buske, Hamburg, pp. 57-81.
Berruto G. (1993), “Le varietà del repertorio”, in Sobrero A. A. (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Laterza, Roma-Bari, pp. 3-36.
Berruto G. (2012), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma.
Berruto G. (2014), “Esiste ancora l’italiano popolare? Una rivisitazione”, in Danler P., Konecny C. (a cura di), Dall’architettura della lingua italiana all’ architettura linguistica dell’Italia. Saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 277-290.
Berruto G. (2016), “Diatopia, diastratia e tratti diagnostici dell’italiano popolare. Il caso di lì”, in Guerini (2016a), pp. 39-77.
Bianco F. (2013), “Le lettere dei migranti irpini fra italiano, dialetto e lingua straniera”, in Albizu C. et al. (a cura di), Variante et varieté – Variante e varietà – Variante y variedad – Variante und Varietät. Actes du VIe Dies Romanicus Turicensis, Zurich, 24-25 juin 2011, ETS, Pisa, pp. 101-117.
Bianco F. (2016), “Burocratese nascosto nell’italiano moderno”, in Ruffino G., Castiglione M. (a cura di), La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione. Atti del XIII Congresso SILFI Società Internazionale di linguistica e Filologia Italiana, Palermo 22-24 settembre 2014, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 519-528.
Bianco F., Špička J. (2017), “Una domanda (ancora) aperta”, in Bianco F., Špička J. (a cura di), Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. Atti del convegno internazionale di studi (Olomouc, 27-28 marzo 2015), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 13-28.
Bruni F. (1978), “Traduzione, tradizione e diffusione della cultura: contributo alla lingua dei semicolti”, in Quaderni storici, 13, 38, pp. 523-554.
Bruni F. (1984), L’italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, UTET, Torino.
Cerruti M. (2003), “Il dialetto oggi nello spazio sociolinguistico urbano. Un’indagine in un quartiere di Torino”, in Rivista Italiana di Dialettologia, 25, pp. 33-88.
Cerruti M. (2009), Strutture dell’italiano regionale. Morfosintassi di una varietà diatopica in prospettiva sociolinguistica, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Cerruti M. (2014), “C’è con soggetto plurale. La realizzazione variabile di un tratto sub-standard dell’italiano contemporaneo”, in Cerruti M., Corino E., Onesti C. (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica sulla variazione diafasica, Dell’Orso, Alessandria, pp. 53-76.
Cerruti M., Ballarè S. (2020), “ParlaTO: corpus del parlato di Torino”, in Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, 44, pp. 171-196.
Chilà A. (2024), “Sul tipo italiano qualche tre chili. Il quantificatore indefinito in unione a numerale”, in Studi e saggi linguistici, 62, 1, pp. 43-71.
Cinque G., Benincà P. (2010), “La frase relativa”, in Renzi L., Salvi G. (a cura di), Grammatica dell’italiano antico, il Mulino, Bologna, Vol. I, pp. 469-507.
Cortelazzo M. (1972), Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, Vol. III, Lineamenti di italiano popolare, Pacini, Pisa.
Cortelazzo M. A. (2001), “L’italiano e le sue varietà: una situazione in movimento”, in Lingua e stile, 36, 3, pp. 417-430.
D’Achille P. (1990), Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. Analisi di testi dalle origini al secolo XVIII, Bonacci, Roma.
D’Achille P. (1994), “L’italiano dei semicolti”, in Serianni L., Trifone P. (a cura di), Storia della lingua italiana, Vol. II, Scritto e parlato, Einaudi, Torino, pp. 41-79.
D’Achille P. (2010), “Italiano popolare”, in Simone R. (a cura di), Enciclopedia dell’italiano, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Treccani, Roma, pp. 723-725:
https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-popolare_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/.
D’Achille P. (2019), “Italiano regionale vs italiano popolare? Le intersezioni tra diatopia e diastratia e la lezione di Manlio Cortelazzo”, in Marcato G. (a cura di), Itinerari dialettali. Omaggio a Manlio Cortelazzo, Cleup, Padova, pp. 93-106.
D’Achille P. (2022), Italiano dei semicolti e italiano regionale. Tra diastratia e diatopia, libreriauniversitaria.it, Limena.
De Mauro T. (1970), “Per lo studio dell’italiano popolare unitario”, nota linguistica a Rossi A., Lettere da una tarantata, Laterza, Bari, pp. 43-75.
Ferguson C. A. (1959), “Diglossia”, in Word, 15, 2, pp. 325-340.
Fresu R. (2014), “Scritture dei semicolti”, in Antonelli G., Motolese M., Tomasin L. (a cura di), Storia dell’italiano scritto, Vol. III, Italiano dell’uso, Carocci, Roma, pp. 195-223.
Fresu R. (2016a), “L’italiano dei semicolti”, in Lubello S. (a cura di), Manuale di linguistica italiana, De Gruyter, Berlin-Boston, pp. 328-350.
Fresu R. (2016b), “Semicolti nell’era digitale: testi, scriventi, fenomeni in e-taliano (popolare?)”, in Lubello S. (a cura di), L’e-taliano. Scriventi e scritture nell’era digitale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 95-120.
Fresu R. (2020). “Dalla devianza al continuum. L’italiano dei semicolti negli studi storico-linguistici: evoluzioni e linee di tendenza”, in Lobin A., Dessì Schmid S., Fesenmeier L. (a cura di), Norm und Hybridität / Ibridità e norma. Linguistische Perspektiven / Prospettive linguistiche, Frank & Timme, Berlin, pp. 249-267.
Ghezzi S. E. (2019), La comunità linguistica di Fornelli tra dinamiche di conservazione e processi di innovazione, tesi di laurea, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli.
Giscel (2011), Sull’impiego delle Prove Invalsi:
https://giscel.it/wp-content/uploads/2017/08/02_NotaInvalsi2011.pdf.
Guerini F. (a cura di)(2016a), Italiano e dialetto bresciano in racconti di partigiani, Aracne, Ariccia.
Guerini F. (2016b), “Il corpus ParVa. Rilevanza per la ricerca e applicazioni didattiche”, in Guerini F. (2016a), pp. 9-38.
Guerini F. (2024), “L’italiano popolare”, in Ballarè S., Fiorentini I., Miola E. (a cura di), Le varietà dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma, pp. 67-80.
Invalsi (2022), Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2021-22: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/rilevazioni_nazionali/rapporto/Sintesi_Prove_INVALSI_2022.pdf.
ISTAT (2020), Rilevazione sulle Forze di lavoro. Giovani dai 18 ai 24 anni d’età che abbandonano prematuramente gli studi:
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_ESL_UNT2020.
ISTAT (2021), Livelli di istruzione e partecipazione alla formazione. Anno 2020:
https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-LIVELLI-DI-ISTRUZIONE-2020.pdf.
ISTAT (2022), “Istruzione e formazione”, in ISTAT, Rapporto BES. Il benessere equo e sostenibile in Italia, pp. 75-95: https://www.istat.it/it/files//2023/04/2.pdf.
ISTAT (2023), Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo:
Lepschy G. C. (2002), “Popular Italian: Fact or Fiction?”, in Lepschy G. C., Mother Tongues and Other Reflections on the Italian Language, University of Toronto Press, Toronto, pp. 49-69.
Lubello S. (a cura di)(2016), L’e-taliano. Scriventi e scritture nell’era digitale, Franco Cesati Editore, Firenze.
Lubello S. (2018), “Scritture da lontano: semicolti campani e sondaggi dal corpus MeTrOpolis”, in Testi e linguaggi, 12, pp. 229-237.
Lubello S., Nobili C. (2018), L’italiano e le sue varietà, Franco Cesati Editore, Firenze.
Mocciaro A. G. (2011): “Alcune considerazioni sull’italiano popolare (con particolare riferimento all’italiano popolare di Sicilia)”, in Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (a cura di), Per i linguisti del nuovo millennio. Scritti in onore di Giovanni Ruffino, Sellerio, Palermo, pp. 322-326.
Renzi L. (2000), “Le tendenze dell’italiano contemporaneo. Note sul cambiamento linguistico nel breve periodo”, in Studi di lessicografia italiana, 17, pp. 279-319.
Sabatini F. (1990), “Una lingua ritrovata: l’italiano parlato”, in Studi latini e italiani, 4, pp. 215-237.
Rosenthal S. (2017), “Data imputations”, in Matthes J. et al. (a cura di), The international encyclopedia of communication research methods:
https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0058.
Sornicola R. (2005), “Processo di italianizzazione e fattori di lungo periodo nella storia sociolinguistica italiana”, in Lo Piparo F., Ruffino G. (a cura di), Gli italiani e la lingua, Sellerio, Palermo, pp. 221-228.
Spitzer L. (1921/1976), Lettere di prigionieri di guerra italiani: 1915-1918, Boringhieri, Torino.
Telmon T. (1990), “Nugae aprutinae. Osservazioni e spunti di discussione sull’italiano regionale abruzzese”, in Berruto G., Sobrero A. A. (a cura di), Studi di sociolinguistica e dialettologia italiana offerti a Corrado Grassi, Congedo, Galatina, pp. 178-197.
Testa E. (2014), L’italiano nascosto, Einaudi, Torino.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2025 Francesco Bianco, Stefania Elisa Ghezzi

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.