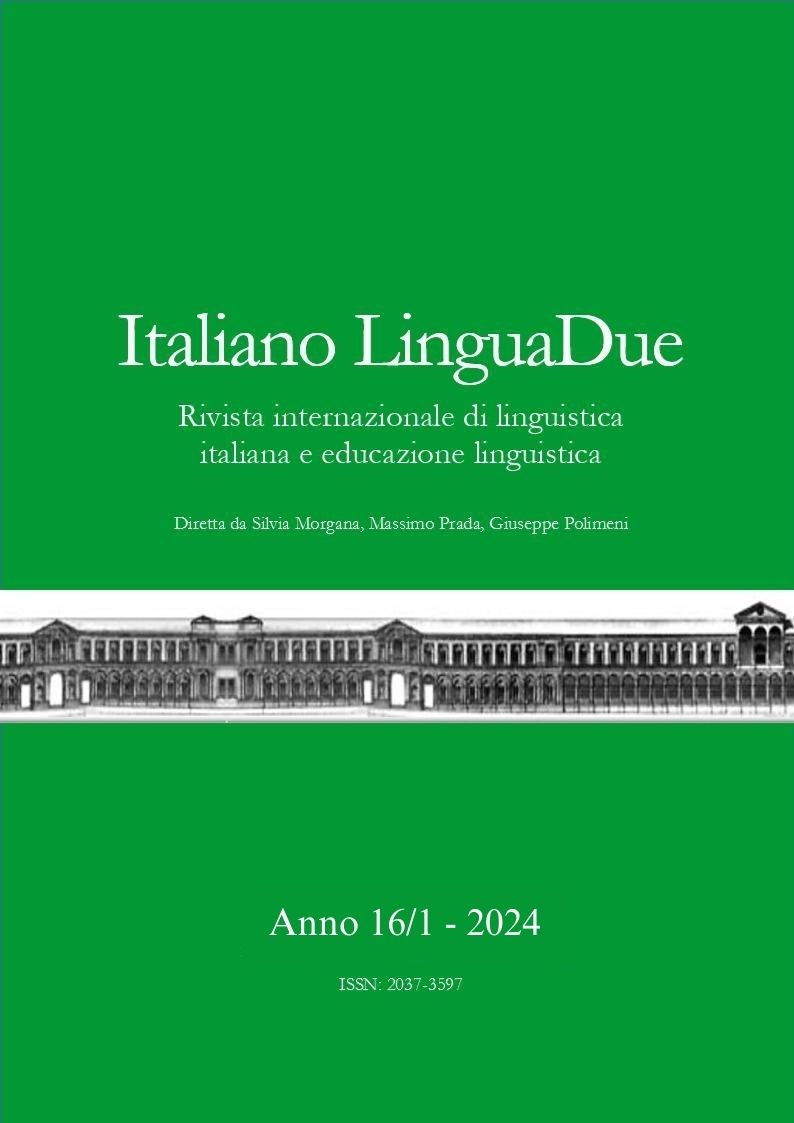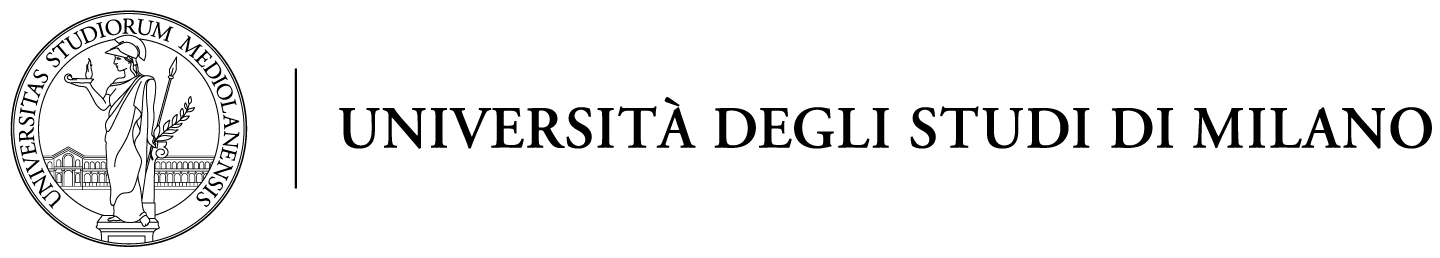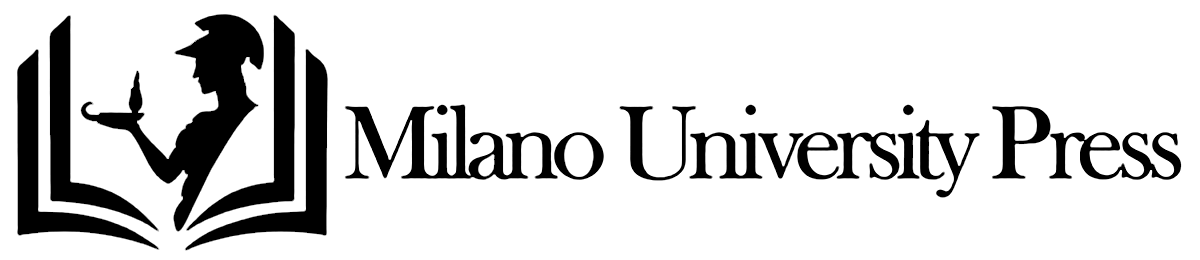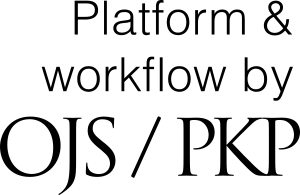COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E EDUCAZIONE LINGUISTICA DEMOCRATICA. IL CONTRIBUTO DEL THINK ALOUD PROTOCOL
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23827Abstract
In questo articolo il tema dell’oscurità linguistica dei linguaggi istituzionali viene messo in relazione con la tendenza degli studenti ad attingere alla varietà burocratica del loro repertorio linguistico nel processo di scrittura formale. In particolare, attraverso proposte didattiche svolte con la verbalizzazione ad alta voce del processo di scrittura (Think Aloud Protocol) e la successiva analisi in griglie è stato possibile possibile osservare la scrittura nel suo farsi e intervenire tempestivamente sulle cristallizzazioni del burocratese. L’analisi e l’autoanalisi del processo di scrittura si è rivelato così uno strumento didattico essenziale per la promozione dell’educazione linguistica democratica.
Institutional Communication and Democratic Language Education. The contribution of the Think Aloud Protocol
In this paper, the linguistic obscurity of institutional languages is related to the students’ tendency to draw on the bureaucratic variety of their linguistic repertoire in the formal writing process. In particular, by means of didactic proposals carried out with Think Aloud Protocol (TAP) and the subsequent analysis in grids, it was possible to observe the writing process and to intervene at an early stage with respect to the crystallisation of bureaucratic language. The analysis and self-analysis of the writing process thus proved to be an essential teaching tool for the promotion of democratic linguistic education.
Riferimenti bibliografici
Amelotti M. (1975), “L’età romana”, in Amelotti M., Costamagna G., Alle origini del notariato italiano, Consiglio nazionale del notariato, Roma, pp. 1-144.
Andorno C. (2014), “Una semplice informalità? Le e-mail di studenti a docenti universitari come apprendistato di registri formali”, in Cerruti M., Corino E., Onesti C. (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica sulla variazione diafasica, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 13-32.
Blanche-Benveniste C. (1990), “Un modele d’analyse syntaxique “en grilles” pour les productions orales”, in Anuario de Psicologia, 47, pp. 11-28.
Bettoni C. (2010), “Come gestire l’errore grammaticale”, in Grassi R., Piantoni M., Ghezzi C. (a cura di), Interazione didattica e apprendimento linguistico, Guerra, Perugia, pp. 163-182.
Bonvino E., Cortes Velasquez D., De Meo A., Fiorenza E. (2023), Agire in L2. Processi e strumenti nella linguistica educativa, Hoepli, Milano.
Cassese S. (1993), “Prefazione”, in Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione pubblica, Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche : proposte e materiali di studio, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello stato, p. 9.
Chini M. (2011), “Qualche riflessione sulla didattica di L2 ispirata alla recente ricerca acquisizionale”, in Italiano LinguaDue, 3, 2, pp. 1-22:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1912.
Ciccarelli R., Pietrandrea P. (2023), “Per un linguaggio chiaro della comunicazione istituzionale. Quale ruolo della linguistica e dei linguisti?”, in Piemontese M. E. (a cura di), Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent’anni dal Codice di stile, Carocci, Roma, pp. 93-109.
Ciccarelli R. (2023), “La retorica online. Interventi per un’educazione linguistica digitale democratica”, in Alsic - Apprentissage des langues et systèmes d’information et de Communication, 26, 1, pp. 146-163.
Cortelazzo M. A. (2021), Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione, Carocci, Roma.
D’Aguanno D. (2019), Insegnare l’italiano scritto, Carocci, Roma.
De Blasi N. (2016), Eduardo, Salerno Editrice, Napoli.
De Mauro, T. (1977), Scuola e linguaggio, Editori Riuniti, Roma.
De Mauro T. (1980), Guida all’uso delle parole, Editori Riuniti, Roma.
De Mauro T., Gensini S., Piemontese M. E. (a cura di) (1988), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione, Atti del XIX Congresso internazionale di studi della SLI – Società di linguistica italiana (Roma, 8-10 novembre1985), Bulzoni, Roma.
De Mauro T., Vedovelli M. (a cura di) (1999), Dante, il gendarme e la bolletta – La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel, Laterza, Bari.
De Mauro T. (2006), “La legge è uguale per tutti?”, in Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di parole. Atti del convegno, Firenze, 13 gennaio 2006. Regione Toscana -Giunta Regionale, Direzione generale dell’Organizzazione e Sistema Informativo, Firenze, pp. 20-23.
Della Putta P. (2020), “Difficoltà di adattamento al contesto comunicativo nella scrittura di studenti universitari italofoni e non italofoni. Il ruolo dell’esperienza varietistica nella didattica della L1 e della L2”, in Grassi R. (a cura di), La scrittura e/per l’apprendimento dell’italiano L2, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 209-224.
Fiorentino G. (2015), “Aspetti problematici del discorso accademico: un’analisi dei riassunti delle tesi di laurea”, in Cuadernos de Filología Italiana, 22, pp. 263-284: https://revistas.ucm.es/index.php/CFIT/article/view/50961.
Grandi N. (2018), “Sulla penetrazione di tratti neo-standard nell’italiano degli studenti universitari. Primi risultati di un’indagine empirica”, in Griseldaonline (sez. Dibattiti): https://griseldaonline.unibo.it/article/view/9021.
Lavinio C., Sobrero A. A. (a cura di) (1991), La lingua degli studenti universitari, La Nuova Italia, Firenze.
Hayes J. R., Flower L. (1981), “A Cognitive Process Theory of Writing”, in College Composition and Communication, 32, pp. 365-387.
Larson P. (2011), “La componente volgare nel latino medievale d'Italia (Interferenze tra latino e volgare nella toscana medievale)”, in Pérez González M., Pérez Rodríguez E. (a cura di), Infuencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval, Universidad de Valladolid, Valladolid.
Lubello S. (2014), L’italiano burocratico, Carocci, Roma.
Lubello S. (2018), “L’antilingua gode di buona salute: nuove forme, vecchi vizi”, in Sergio G. (a cura di), Comunicare cittadinanza nell’era digitale Saggi sul linguaggio burocratico 2.0, FrancoAngeli, Milano, pp. 31-43.
Lucisano P., Piemontese M. E. (1988), “Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana”, in Scuola e città, 39, 3, pp. 110-124.
Pallotti G. (2017), “Applying the interlanguage approach to language teaching”, in International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 55, 4, pp. 393-412.
Piemontese M. E. (1996), Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata, Tecnodid, Napoli.
Piemontese M. E. (2020), “Il contributo di don Lorenzo Milani all’educazione linguistica democratica”, in Casini C., Sansalone C., Bancheri S., Lettieri M. (a cura di), Un viaggio attraverso la conoscenza. Studi in memoria di Paul A. Colilli (1952-2018) – A Journey through Knowledge. A Festschrift in Memory of Paul A. Colilli (1952-2018), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 561-581.
Raso T. (2005), La scrittura burocratica. La lingua e l’organizzazione del testo, Carocci, Roma.
Selinker L. (1972), “Interlanguage”, in Richards J. (ed.), Error analysis: perspectives on second language acquisition, Longman, London, pp. 31-54.
Sornicola R. (2012), “Potenzialità e problemi dell’analisi linguistica dei documenti notarili alto-medievali dei domini bizantini e longobardi, in Sornicola R., Greco P. (a cura di), La lingua dei documenti notarili alto-medievali dell’Italia meridionale. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca, Tavolario Edizioni, Cimitile, pp. 9-62.
Vellutino D. (2018), L’italiano istituzionale per la comunicazione pubblica, il Mulino, Bologna.
Voghera M. (2017), Dal parlato alla grammatica, Carocci, Roma.
Dowloads
Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.