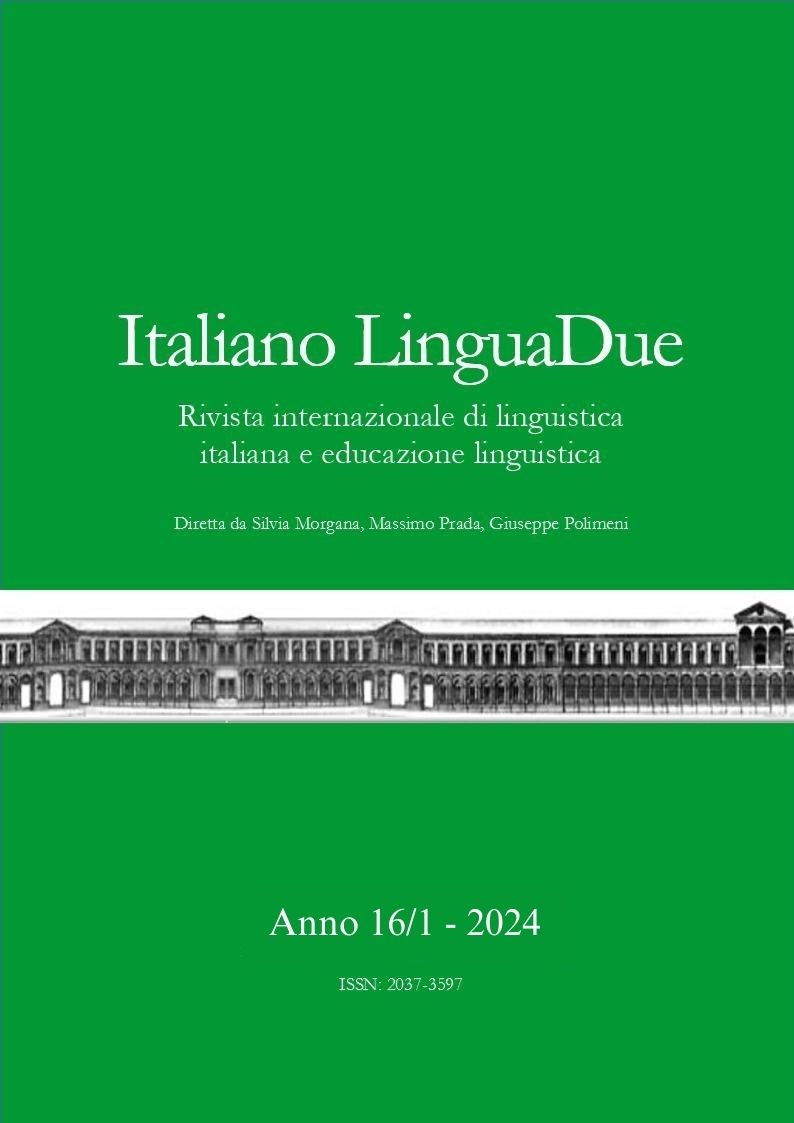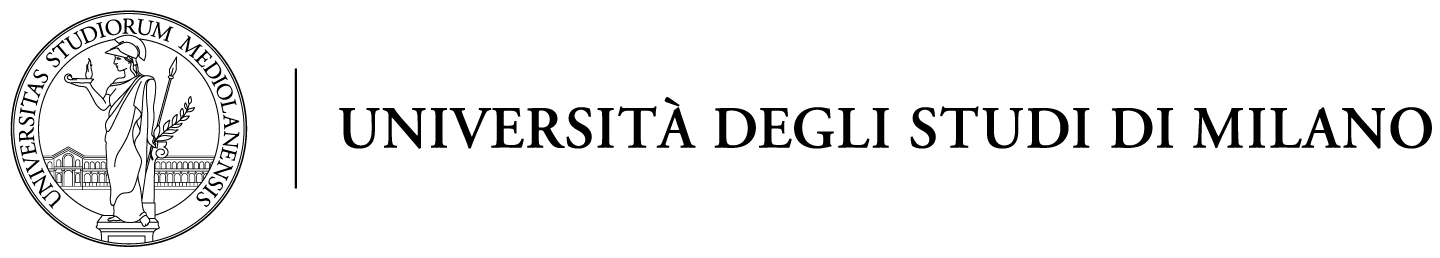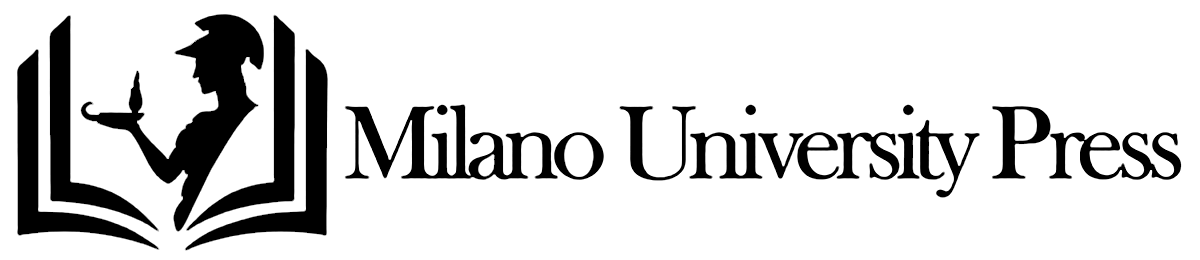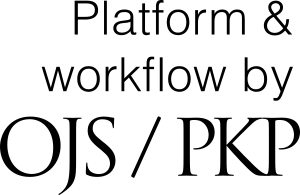UN PROGETTO NAZIONALE SULL’ITALIANO ISTITUZIONALE SVIZZERO. UN BILANCIO TRA PERCORSI DI RICERCA, RISULTATI SCIENTIFICI E APPLICAZIONI
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23834Abstract
L’articolo propone un bilancio provvisorio di un progetto di ricerca in corso dal 2020 all’Università di Basilea, il cui oggetto di analisi è l’italiano istituzionale svizzero. Il progetto vuole descrivere, spiegare e valutare le peculiarità di questa varietà linguistica e le caratteristiche specifiche dei generi testuali in cui essa si realizza. L’obiettivo del bilancio qui proposto è duplice: valutare con occhio critico le scelte fatte nell’ambito del progetto e fare il punto sui risultati raggiunti, con attenzione ai prodotti concreti della ricerca (volumi, articoli, convegni ecc.). Quanto al primo aspetto, si mostra quali sono state le linee di ricerca contenutistiche e metodologiche via via perseguite: si sottolineano da una parte le scelte che si sono rivelate virtuose – come ad esempio la stretta collaborazione con chi opera concretamente nelle Cancellerie svizzere – e dall’altra gli arricchimenti e gli aggiustamenti che il confronto con la realtà della ricerca ha reso necessari – per esempio, per quanto riguarda l’analisi, il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica del corpus o, per quanto riguarda la valutazione, la tematizzazione dell’italiano svizzero quale lingua pluricentrica –. Quanto al secondo aspetto, si mostra come le linee di ricerca del progetto disegnino nel complesso un quadro articolato dell’italiano istituzionale svizzero, che tocca numerosi contesti d’uso (Costituzione svizzera, web e social media, lingua facile, comunicazione legata al Covid) e confronti significativi (con l’italiano istituzionale d’Italia, con le altre lingue ufficiali svizzere, con l’italiano di Svizzera come centro autonomo di elaborazione linguistica).
A national project on Swiss institutional Italian. A review of research paths, scientific results and applications
The paper implements a provisional report of a research project in progress since 2020 at the University of Basel, whose object of analysis is Swiss institutional Italian. The project aims to describe, explain and evaluate the peculiarities of this language variety and the specific characteristics of the text genres realizing it. The aim of the report is twofold: to critically evaluate the choices made within the project and to take stock of the results achieved, with attention to concrete research outputs (volumes, articles, conferences, etc.). As for the first aspect, the paper describes the content and methodological lines of research that were pursued: on the one hand, the choices that turned out to be virtuous – such as, e.g., the close collaboration with people working in the Swiss Chancelleries – and, on the other hand, the enrichments and adjustments that the confrontation with the reality of research made necessary – e.g., as far as the analysis is concerned, the transition from a static to a dynamic conception of the corpus or, as far as evaluation is concerned, the thematization of Swiss Italian as a pluricentric language – are emphasized. As for the second aspect, the paper shows how the research avenues of the project draw an articulated picture of Swiss institutional Italian, touching on several contexts of use (Swiss Constitution, web and social media, easy-to-read language, Covid-related communication) and significant comparisons (with the institutional Italian of Italy, with the other Swiss official languages, with Swiss Italian as an autonomous center of linguistic elaboration).
Downloads
Riferimenti bibliografici
Studi dell’équipe di ricerca
Carlevaro A., Ferrari A., Pecorari F. (2023), “Microtestualità amministrative. Tendenze del francese elvetico tra tedesco e italiano”, in De Cesare A.-M., Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), Forme della scrittura italiana contemporanea in prospettiva contrastiva. La componente testuale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 185-201.
Egger J.-L., Ferrari A. (in stampa), “L’italiano istituzionale”, in Natale S., Kunz A. (a cura di), L’italiano in Svizzera / Italienisch in der Schweiz, Peter Lang, Bern-Berlin. Egger J.-L., Ferrari A. (in prep.), I profili dell’italiano istituzionale tra Svizzera e Italia, Accademia della Crusca, Firenze.
Egger J.-L., Ferrari A., Lala L. (a cura di) (2013), Forme linguistiche dell’ufficialità. L’italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera, Casagrande, Bellinzona.
Evangelista D., Piantanida G., Tonani G. (2023), “L’avverbio segnatamente nella legislazione plurilingue svizzera: usi, funzioni e equivalenti testuali”, in De Cesare A.-M., Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), Forme della scrittura italiana contemporanea in prospettiva contrastiva. La componente testuale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 103-115.
Evangelista D., Marengo T., Piantanida G., Tonani G. (in stampa), “Strategie di codifica della temporalità nei testi istituzionali svizzeri in prospettiva contrastiva”, in Dessì Schmid S. (a cura di), in Atti del XVI Congresso SILFI “Tempo e spazio: forme, testi, storia”, Franco Cesati Editore, Firenze.
Ferrari A. (2022a), “Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto, tra morfologia, sintassi e testualità”, in Ferrari et al. (2022b), pp. 3-20.
Ferrari A. (2022b), “Dalla ‘lingua chiara’ alla ‘lingua facile’, ovvero delle rinunce – necessarie? utili? – alla testualità”, in Mollica A., Onesti C. (a cura di), Studi in onore di Carla Marello, Soleil, Welland, pp. 103-114.
Ferrari A., De Cesare A.-M., Evangelista D., Lala L., Marengo T., Pecorari F., Piantanida G., Rosi B. (2022a), “Il corpus It-Ist_CH: un corpus rappresentativo dell’italiano istituzionale svizzero”, in Baranzini L., Casoni M., Christopher S. (a cura di), Linguisti in contatto 3. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Bellinzona, pp. 57-70.
Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di) (2022b), L’italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia, Edizioni Dell’Orso, Alessandria.
Ferrari A., Carlevaro A., Evangelista D., Lala L., Marengo T., Pecorari F., Piantanida G., Tonani G. (a cura di) (2024), La comunicazione istituzionale durante la pandemia in Ticino, con uno sguardo ai Grigioni, Casagrande, Bellinzona.
Ferrari A., Lala L., Marengo T., Piantanida G. (in prep.), “Le specificità sintattiche dell’italiano istituzionale elvetico: un confronto tra i testi informativi svizzeri e italiani in tempi di Covid-19”, in Baranzini L. et al. (in prep.).
Ferrari A., Pecorari F. (2022a), Linguaggio inclusivo di genere. Guida all’uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione:
Ferrari A., Pecorari F. (2022b), Le buone pratiche redazionali nei testi istituzionali svizzeri in lingua italiana, Franco Cesati Editore, Firenze.
Ferrari A., Pecorari F. (in stampa), “L’inclusione di genere nei testi ufficiali, tra maschile inclusivo e pratiche di scrittura alternative. Le scelte della Svizzera multilingue con focus sull’italiano”, in Lingue e culture dei media.
Ferrari A., Sciumbata F. C. (2023), “Il problema della testualità nella lingua easy-to-read. Ricognizioni e sistemazioni, anche in vista di valutazioni sperimentali”, in Studi italiani di linguistica teorica e applicata, LII, 2, pp. 312-332.
Lala L. (2013), “Le pagine Web dell’Amministrazione federale svizzera: aspetti linguistici e comunicativi della versione in lingua italiana”, in Egger J.-L. et al. (2013), pp. 99-134.
Lala L. (2014), “I linguaggi dell’amministrazione pubblica: online vs offline, italiano d’Italia vs italiano elvetico”, in Korzen I., Ferrari A., De Cesare A.-M. (a cura di), Between Romance and Germanic: language, text, cognition and culture/Tra romanistica e germanistica: lingua, testo, cognizione e cultura, Peter Lang, Bern, pp. 237-256.
Lala L. (2022a), “Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera”, in Ferrari et al. (2022b), pp. 21-49.
Lala L. (2022b), “La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un confronto”, in Ferrari et al. (2022b), pp. 51-66.
Lala L. (2024a), “La lingua della norma nell’emergenza sanitaria: l’italiano della normativa Covid della Confederazione Elvetica”, in Ferrari et al. (2024), pp. 51-73.
Lala L. (2024b), “La lingua della norma nell’emergenza sanitaria: l’italiano della normativa Covid nel Canton Ticino”, in Ferrari et al. (2024), pp. 75-96.
Lala L. (in stampa), “La lingua della norma Covid-19 nella Confederazione svizzera e in Canton Ticino”, in Kwartalnik Neofilologiczny, LXXII, 4, 2023.
Marengo T. (2022), “Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana”, in Ferrari et al. (2022b), pp. 179-200.
Pecorari F. (2022), “L’implicito e le sue funzioni nella Costituzione svizzera in lingua italiana: quali specificità rispetto alla Costituzione italiana?”, in Ferrari et al. (2022b), pp. 135-159.
Pecorari F. (a cura di) (2023a), Le istituzioni pubbliche sui social media: lingua e comunicazione. Les institutions publiques sur les réseaux sociaux : langue et communication (=Bulletin suisse de linguistique appliquée, 118).
Pecorari F. (2023b), “Sistemi di traduzione assistita e testualità: un’analisi di testi istituzionali della Confederazione Svizzera”, in Gatta F., Mazzoleni M. (a cura di), Linguistica e traduzione oggi: un approccio testualista (=Studi italiani di linguistica teorica e applicata, LII, 3, pp. 533-551.
Pecorari F. (2024), “I cantoni svizzeri italofoni sui social network in tempo di pandemia: alcune osservazioni linguistiche e testuali”, in Ferrari et al. (2024), pp. 187-216.
Pecorari F. (2024), “#covid19: specificità della comunicazione digitale nei social network istituzionali ticinesi e grigionesi”, in Ferrari et al. (2024), pp. 217-239.
Pecorari F., Carlevaro A., Evangelista D., Tonani G. (in prep.), “Statalismi istituzionali: un’analisi corpus-based dell’apporto dell’italiano istituzionale all’italiano di Svizzera”, in Baranzini L. et al. (in prep.).
Piantanida G. (2024), “Tra l’amministrazione e i cittadini: lingua e testualità delle FAQ svizzere sulla pandemia”, in Ferrari et al. (2024), pp. 141-160.
Altri studi
Ammon U. (2017), “On the social forces that determine what is standard in a language – with a look at the norms of non-standard language varieties”, in Pandolfi E. M. et al. (eds.), Studies on Language Norms in Context, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 17-35.
Baranzini L., Moskopf-Janner M. C. (2020), “Norm-setting authorities for a weakly pluricentric language: the case of Italian in Switzerland”, in Muhr R., Thomas J. (eds.), Pluricentric Theory beyond Dominance and Non-dominance, PCL-PRESS, Graz-Berlin, pp. 137-150.
Baranzini L., Casoni M., Christopher S. (a cura di) (in prep.), Le lingue pluricentriche: il caso dell’italiano, PCL-PRESS, Graz.
Berruto G. (1984), “Appunti sull’italiano elvetico”, in Studi linguistici italiani, 10, pp. 76-108.
Biagini F. (2023), “Aspetti linguistici della traduzione tra l’italiano e il russo: il caso della segmentazione del testo in enunciati”, in Gatta F., Mazzoleni M. (a cura di), Linguistica e traduzione oggi: un approccio testualista (=Studi italiani di linguistica teorica e applicata, LII, 3, pp. 313-330.
Egger J.-L. (2019), A norma di (chi) legge. Peculiarità dell’italiano federale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
Fiorelli P. (2008), Intorno alle parole del diritto, Giuffrè, Milano.
Fioritto A. (a cura di) (1997), Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna.
Franceschini F., Gigli S. (a cura di) (2003), Manuale di scrittura amministrativa, Agenzia delle Entrate, Roma.
ITTIG, Accademia della Crusca (2011), Guida alla redazione degli atti amministrativi,
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf.
Lubello S. (2016), “Usi pubblici e istituzionali dell’italiano”, in Lubello S. (a cura di), Manuale di linguistica italiana, Walter De Gruyter, Berlin-Boston, pp. 417-441.
Lubello S. (2017), La lingua del diritto e dell’amministrazione, il Mulino, Bologna.
Lubello S. (2018a), “Buone e cattive pratiche burocratiche”, in Bombi R. (a cura di), Dalla semplificazione all’openness. Il terzo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale, Il Calamo, Roma, pp. 117-130.
Lubello S. (2018b), “L’antilingua gode di buona salute: nuove forme, vecchi vizi”, in Cattani P., Sergio G. (a cura di), Comunicare cittadinanza nell’era digitale. Saggi sul linguaggio burocratico 2.0, FrancoAngeli, Milano, pp. 31-43.
Lumbelli L. (1989), Fenomenologia dello scrivere chiaro, Editori Riuniti, Roma.
Mortara Garavelli B. (2001), Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino.
Pandolfi E. M. (2009), LIPSI. Lessico di frequenza dell’italiano parlato nella Svizzera italiana, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Bellinzona.
Pandolfi E. M. (2017), “Italian in Switzerland: the dynamics of pluricentrism”, in Cerruti M., Crocco C., Marzo S. (a cura di), Towards A New Standard: Theoretical and Empirical Studies on the Restandardization of Italian, de Gruyter, Berlin, pp. 321-362.
Piemontese M. E. (1996), Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata, Tecnodid, Napoli.
Pontrandolfo G. (2023), “Aspetti testuali nella traduzione della divulgazione scientifica”, in De Cesare A.-M., Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), Forme della scrittura italiana contemporanea in prospettiva contrastiva. La componente testuale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 283-300.
Raso T. (2007), La scrittura burocratica. La lingua e l’organizzazione del testo, Carocci, Roma.
Rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale (2012), Chiarezza e traduzione. Atti della XII giornata REI, Lussemburgo.
Sabatini F. (2005), “I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua”, in Borghi M. (a cura di), Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero, CFPG-Helbing & Lichtenhahn, Lugano-Basilea, pp. 17-25.
Vellutino D. (2018), L’ italiano istituzionale per la comunicazione pubblica, il Mulino, Bologna.
Visconti J. (a cura di) (2010), Lingua e diritto. Livelli di analisi, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.