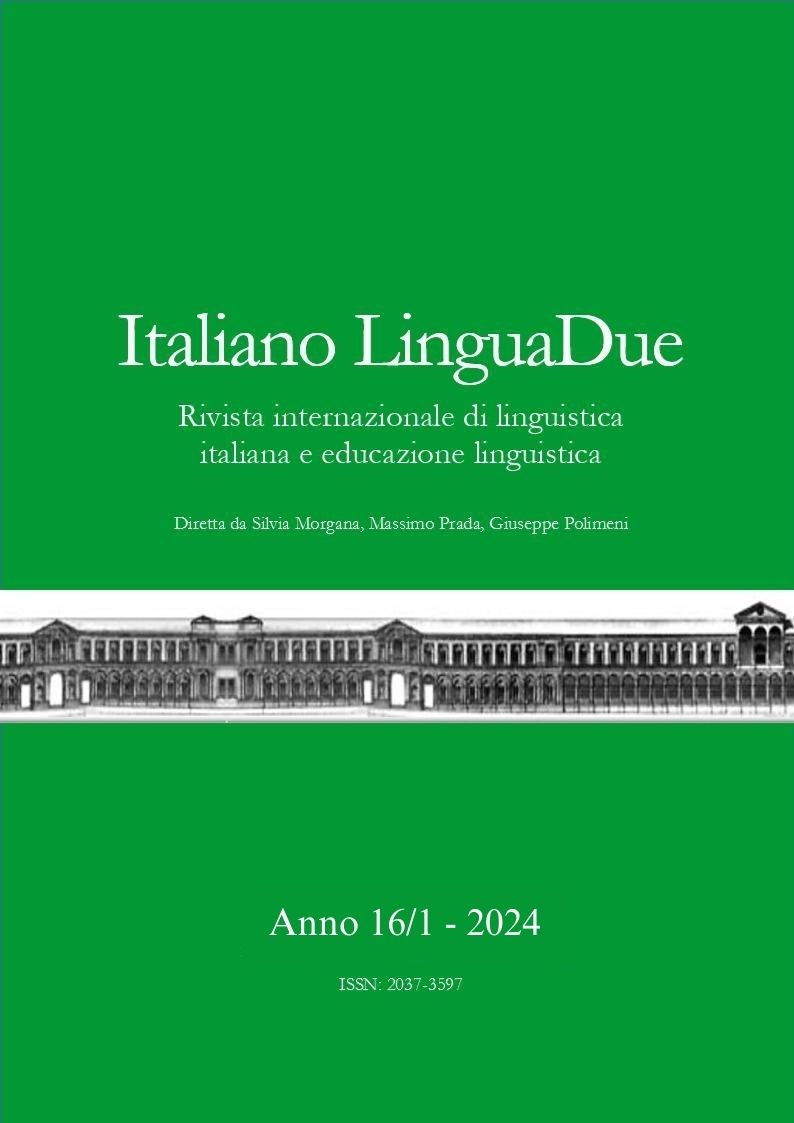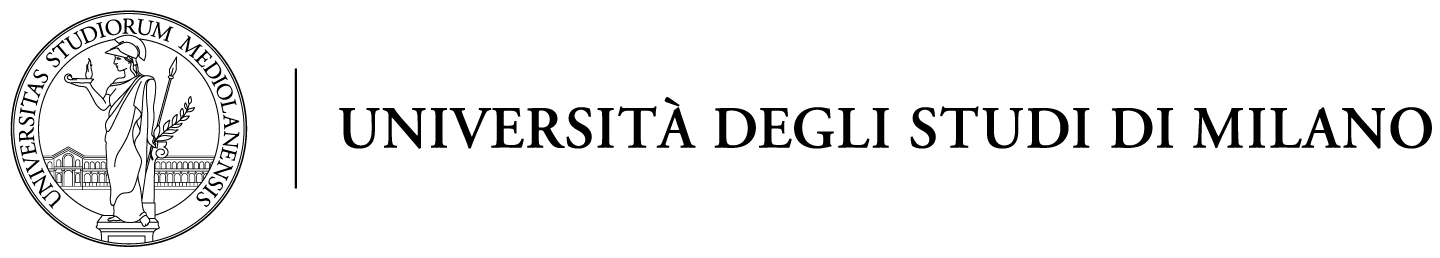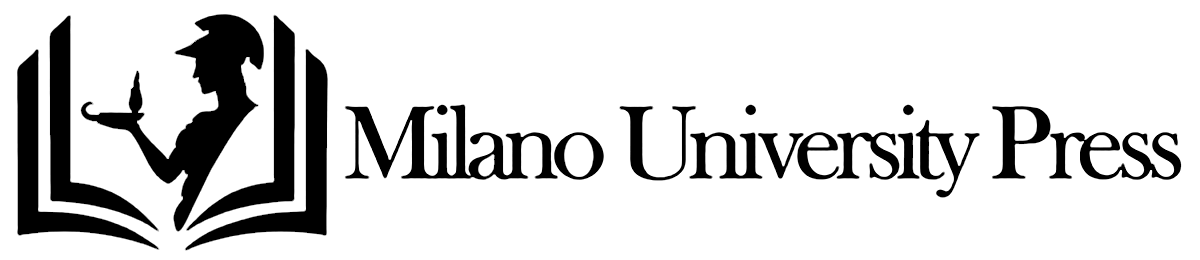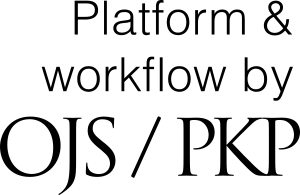SCRITTURA ED ELENCHI PUNTATI NEI TESTI ESPOSITIVI: TRA SINTASSI E TESTUALITÀ
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23882Abstract
Il saggio esplora l’uso che si fa oggi di un particolare dispositivo testuale chiamato “elenco puntato”, al confine tra frase e testo, il cui scopo è elencare e scandire contenuti in modo chiaro e trasparente, al fine di facilitare il lettore nella comprensione e nella messa a fuoco degli elementi chiave di una descrizione, o dei concetti chiave di un ragionamento. L’indagine è limitata a testi espositivi scritti di medio-alta formalità, di ambito linguistico/educativo, prodotti da autori di provata affidabilità. Sulla base di caratteristiche formali ben riconoscibili – struttura sintattica, uso della punteggiatura, organizzazione dello spazio – vengono individuati e descritti tre diversi tipi di elenchi puntati: con i primi due siamo nell’ambito della frase, dove operano vincoli sintattici che possono essere spezzati solo da un uso fortemente marcato della punteggiatura; con il terzo tipo siamo nell’ambito del testo, il cui unico vincolo è la coerenza concettuale.
Writing and Numbered Lists in Expository Texts: Between Syntax and Text
This article explores the use made today of a particular textual device called “numbered list”. On the borderline between sentence and text, the numbered list is used to list and articulate contents clearly and transparently, so as to help the reader understand and focus on the key elements of a description, or the key concepts of a line of reasoning. The investigation is limited to Italian written expository texts of medium-high formality, in the fields of linguistics and education, produced by authors of proven reliability. On the basis of easily recognizable formal characteristics – syntactic structure, use of punctuation, spatial organization – three different types of numbered lists are identified and described: with the first two we are in the context of the sentence, where syntactic constraints apply which can only be broken in the presence of a strongly marked use of punctuation; with the third type we are in the context of the text, where the only constraint is conceptual coherence.
Downloads
Riferimenti bibliografici
Andreose A. (2017), Nuove grammatiche dell’italiano. Le prospettive della linguistica contemporanea, Carocci, Roma.
Baratter P. (2018), Il punto e virgola. Storia e usi di un segno, Carocci, Roma.
Bruni F. et al. (2006), Manuale di scrittura e comunicazione. Per l’università. Per l’azienda, Zanichelli, Bologna.
Calvani A., Trinchero R. (2019), Dieci falsi miti e dieci regole per insegnare bene, Carocci Faber, Roma.
Cignetti L., Demartini S., Fornara S. (2016), Come TIscrivo? La scrittura a scuola tra teoria e didattica, Aracne, Roma.
Cignetti L., Demartini S., Fornara S., Viale M. (2022), Didattica dell’italiano come lingua prima, il Mulino, Bologna.
Corno D. (2010), La tastiera e il calamaio. Come si scrive all’università, studi e ricerche, Edizioni Mercurio, Torino.
Dehaene S. (2019), Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Raffaello Cortina, Milano (titolo originale: How we learn, 2019).
De Roberto E. (2023), La sintassi della frase complessa, il Mulino, Bologna.
De Santis C., Fiorentino G. (2018), “La carica dei 600: la campagna mediatica sul declino della lingua italiana”, in Circula. Revue d’idéologies linguistiques, 7, pp. 1-28:
https://core.ac.uk/download/pdf/199229126.pdf.
Giunchi P., Roccaforte M. (2021), La grammatica tra acquisizione e apprendimento. Un percorso verso la consapevolezza linguistica, Carocci, Roma.
Ferrari A. (2014), Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture, Carocci, Roma.
Ferrari A. (2016), “Le gerarchie del testo, tra lessico, sintassi e interpunzione”, in Cignetti L., Demartini S., Fornara S. (a cura di), pp. 121-137.
Ferrari A. (2018a), “La funzione comunicativo-testuale della punteggiatura”, in Ferrari et al., 2018, pp. 15-23.
Ferrari A. (2018b), “La virgola”, in Ferrari et al., 2018, pp. 49-63.
Ferrari A. (2018c), “Il punto e virgola”, in Ferrari et al., 2018, pp. 65-81.
Ferrari A. (2018d), “Il punto a capo”, in Ferrari et al., 2018, pp. 95-107.
Ferrari A., Lala L. (2013), “La virgola nell’italiano contemporaneo. Per un approccio testuale (più) radicale”, in Studi di grammatica italiana, XXIX-XXX, pp. 479-501.
Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (2017), L’interpunzione oggi (e ieri). L’italiano e altre lingue europee, Franco Cesati Editore, Firenze.
Ferrari A., Lala L., Zampese L. (2021), Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi, Carocci, Roma.
Ferrari et al. (2018), La punteggiatura italiana contemporanea. Un’analisi comunicativo-testuale, Carocci, Roma.
Gheno V. (2022), Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma:
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Schwa/4Gheno.html.
Gualdo R., Raffaelli L., Telve S. (2014), Scrivere all’università. Pianificare e realizzare testi efficaci, Carocci, Roma.
Grandi N. (2021), “La frase in prospettiva tipologica”, in Prandi et al., (a cura di), Orizzonti della linguistica. Grammatica, tipologia, mutamento, Carocci, Roma, pp. 143-174.
Hattie J. (2016), Apprendimento visibile, insegnamento efficace. Metodi e strategie di successo dalla ricerca evidence-based, Erickson, Trento.
Inglese G., Luraghi S. (2023), Le categorie grammaticali, Carocci, Roma.
Lavinio C. (20222), Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica trasversale, Carocci, Roma.
Lo Duca M. G. (2023), Dizionario di base della grammatica italiana, Carocci, Roma.
Marotta G., Vanelli L. (2021), Fonologia e prosodia dell’italiano, Carocci Roma.
Mortara Garavelli B. (2003), Prontuario di punteggiatura, Laterza, Roma-Bari.
Pallotti G., Borghetti C., Rosi F. (2021), Insegnare a scrivere nella scuola primaria. Il progetto Osservare l’interlingua, Caissa Italia, Cesena-Bologna.
Piemontese M. E., Sposetti P. (2014), La scrittura dalla scuola superiore all’università, Carocci, Roma.
Pistolesi E., Pugliese R. (2023), “Numeri per argomentare: strategie di dispositio nelle produzioni scritte degli studenti universitari”, in Globe: a journal of language, culture and communication, 17, pp. 214-224:
https://journals.aau.dk/index.php/globe/article/view/8213/6608.
Restivo M. L. (2022), “L’italiano scritto degli studenti universitari: prime osservazioni sul corpus UniverS-Ita”, in Italiano LinguaDue, 14, 1, pp. 797-818:
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/18328/16235.
Roncoroni F. (2010), Manuale di scrittura non creativa, Rizzoli, Milano.
Rosi B. (2018), “Le (complesse) interazioni tra sintassi e punteggiatura: le subordinate causali introdotte da ‘perché’”, in Ferrari et al., 2018, pp. 35-48.
Sabatini F., Camodeca C. (2022), Grammatica valenziale e tipi di testo, Carocci, Roma.
Serianni L. (2001), “Sul punto e virgola nell’italiano contemporaneo”, in Studi linguistici italiani, 27, 2, pp. 248-255.
Simone R. (2022), La grammatica presa sul serio. Come è nata, come funziona e come cambia, Laterza, Bari-Roma.
Stojmenova R. (2017), “I due punti nell’italiano contemporaneo: segmentazione e organizzazione del testo”, in Ferrari, Lala, Pecorari (2017), pp. 59-73.
Stojmenova R. (2018), “I due punti”, in Ferrari et al. (2018), pp. 155-166.
Teruggi L. A. (2019), Leggere e scrivere a scuola: dalla ricerca alla didattica, Carocci, Roma.
Voghera M. (2017), Dal parlato alla grammatica. Costruzione e forma dei testi spontanei, Carocci, Roma.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Maria G. Lo Duca

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.