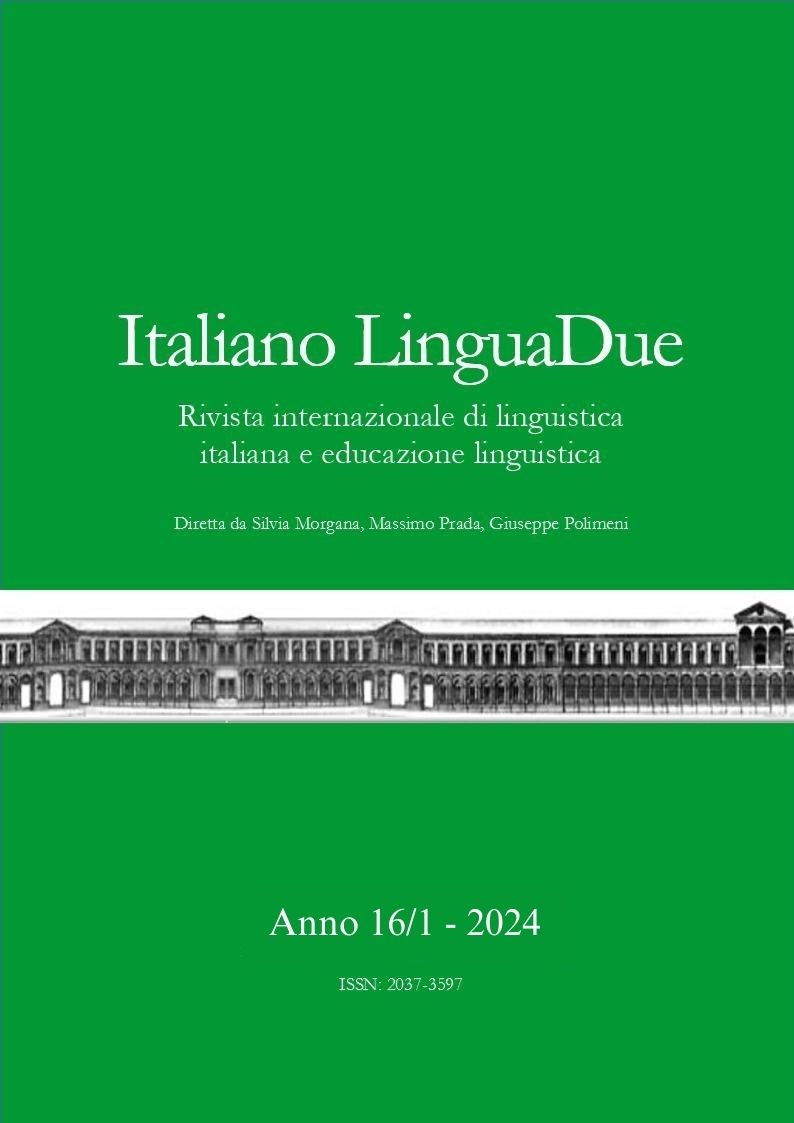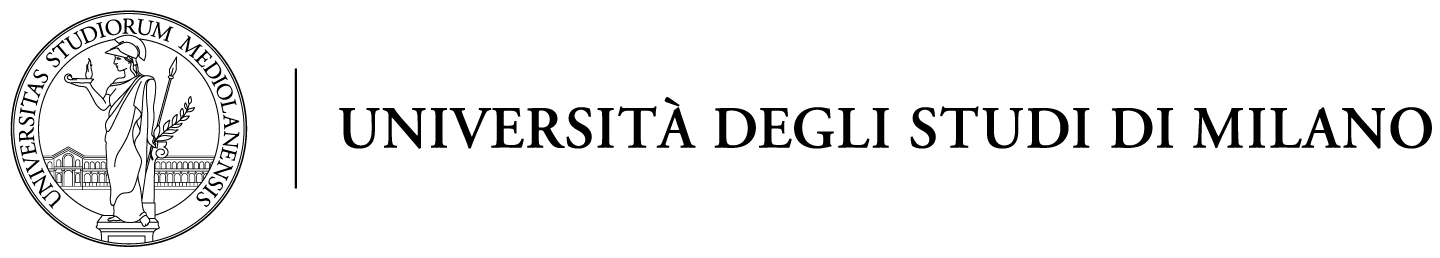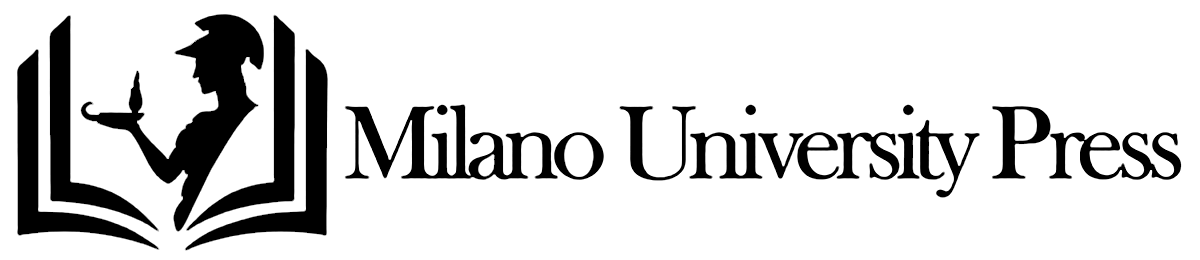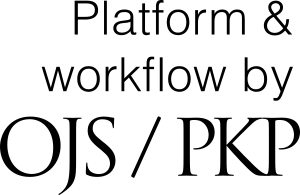LA RISCOPERTA DE’ L’ORTOGRAFIA ITALIANA ET ALTRE OSSERVATIONI DELLA LINGUA DI ALTOBELLO GAGLIARO (1631)
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23887Abstract
Nell’ottica del più ambizioso progetto di riscoperta delle opere grammaticali del Seicento, trascurate dalla moderna letteratura scientifica, si inserisce il presente contributo, dedicato all’Ortografia italiana et altre osservationi della lingua di Altobello Gagliaro (1631). Oltre allo studio di una grammatica dimenticata e, quindi, alla ricostruzione della storia dell’opera e alla descrizione dei contenuti, l’articolo si propone di evidenziare alcune non trascurabili riflessioni di natura sintattica con cui l’autore, sovente, costella la riflessione metalinguistica. La sicura distinzione tra i concetti di periodo e membro, la frequenza con cui fa ricorso alle nozioni di dipendenza e reggenza, l’abbozzo di una rudimentale analisi del periodo e altre intuizioni, assieme all’impiego di una precisa terminologia tecnica, rendono l’opera meritevole di attenzione, permettendo di descrivere e conoscere un autore che sentì il bisogno di supportare le asserzioni sulla lingua con l’analisi di unità maggiori alla parola e che produsse riflessioni puntuali che testimoniano il perfezionamento teorico di quanto già acquisito nel secolo precedente.
The rediscovery of L'ortografia italiana et altre osservationi della lingua by Altobello Gagliaro (1631)
The present contribution, dedicated to Altobello Gagliaro’s Ortografia italiana et altre osservationi della lingua (1631), is part of the more ambitious project of rediscovering grammatical works of the 17th century that have been neglected by modern scholarly literature. In addition to the study of a forgotten grammar and, therefore, the reconstruction of the work’s history and the description of its contents, the article aims to highlight some not-inconsiderable reflections of a syntactic nature with which the author often punctuates his metalinguistic reflections. The clear distinction between the concepts of periodo and membro, the frequency with which he makes use of the notions of dependency and regency, the outline of a rudimentary analysis of propositions and other intuitions, together with the use of precise technical terminology, make the work worthy of attention, allowing us to describe and get to know an author who needed to support his assertions on language with the analysis of units greater than a single word and who produced precise reflections that bear witness to the theoretical refinement of what he had already acquired in the previous century.
Downloads
Riferimenti bibliografici
AA.VV., Vocabolario Treccani online, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma:
http://www.treccani.it/vocabolario/.
Antonelli G., Motolese M., Tomasin L. (a cura di) (2014-2021), Storia dell’italiano scritto, 6 voll., Roma, Carocci.
Bartoli D. (1670), Dell’Ortografia italiana, Trattato del P. D. B, in Roma, A spese d’Ignatio de Lazari.
BibIt = Biblioteca italiana: biblioteca digitale di testi: www.bibliotecaitaliana.it.
Bonomi I. (2012), La grammaticografia italiana attraverso i secoli, CUEM Edizioni Unicopoli, Milano.
Buommattei B. (1643), Della lingua toscana di Benedetto Buommattei, Pubblico Lettor di essa nello Studio Pisano, e nell’Accademia Fiorentina, Libri due, Impressione Terza, In Firenze, Per Zanobi Pignoni.
Cantimori (1976), “L’età barocca”, in Caretti L., Luti G. (a cura di), La letteratura italiana: per saggi storicamente disposti, Il Seicento, vol. IV, Mursia, Milano, pp. 9-17.
Ceci G. B. (1618), Compendio d’avvertimenti di ben parlare volgare, correttamente scrivere, e comporre lettere di negocio, e complimenti, in Venezia, Nella Stamperia Salicata.
Chiantera A. (1986), “Alle origini della punteggiatura”, in Italiano e oltre, 4, pp. 149-152.
Chiantera A. (1992), Le regole interpuntive nella trattatistica cinquecentesca, in Cresti E., Maraschio N., Toschi L. (a cura di), Storia e teoria dell’interpunzione. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 19-21 maggio 1988, Bulzoni, Roma, pp. 191-203.
Cinonio (1644), Delle osservationi della Lingua Italiana dal Cinonio Academico Filergita, raccolte in gratia d’un Predicator Siciliano, Parte Seconda, In Ferrara, Per Giuseppe Gironi Stampatore Espisc.
Colombo A., Graffi G. (2020), Capire la grammatica. Il contributo della linguistica, Carocci, Roma.
Corso R. (1564), Fondamenti del parlar thoscano di Rinaldo Corso nella sua vera, & sana, & original lettione rappresentati, in Roma, per Antonio Blado.
Cresti E., Maraschio N., Toschi L. (a cura di) (1992), Storia e teoria dell’interpunzione. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze, 19-21 maggio 1988, Bulzoni, Roma.
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960 e ss.
DELI = Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, DELI – Dizionario etimologico della lingua italiana, seconda edizione in volume unico, Zanichelli, Bologna, 1999.
Foffano F. (1897), Ricerche Letterarie, Livorno, Tipografia di Raff. Giusti Editore Libraio.
Fornara S. (2005), Breve storia della grammatica italiana, Carocci, Roma.
Fornara S. (2010), La punteggiatura, Carocci, Roma.
Fornara S. (2013), La trasformazione della tradizione nelle prime grammatiche italiane (1440-1555), Aracne, Roma.
Fornara S. (2019), Breve storia della grammatica italiana, Carocci, Roma.
Fortunio G. F. (1516), Regole grammaticali della volgar lingua, Ancona, presso Bernaldino Guerrarda.
Franzoni D. (1641), L’Oracolo della lingua d’Italia, Bologna, Per Carlo Zenero e Giacomo Monti.
Gagliaro A. (1631), L’ortografia italiana et altre osservationi della lingua, D’Altobello Gagliaro da Buccino, Academico Napolitano, Napoli, Stamperia di Matteo Nucci.
Getto G. (2000), Il barocco letterario in Italia, Mondadori, Milano.
Graffi G. (2004) (a c. di), Fortuna e vicissitudini di concetti grammaticali, Unipress, Padova.
HEL = Histoire, épistémologie, langage (HEL), revue publiée par la Societé d’histoire et d’épistemologie des sciences du langage et le Centre interdisciplinaire de recherches en linguistique de Lille III, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, Université Paris VII.
Lala L. (2020), “Punto fermo, interrogativo e ammirativo: note sulla trattatistica secentesca”, in Ferraro A., Lala L., Pecorari F., Stojmenova Weber R. (a cura di), Capitoli di storia della punteggiatura italiana, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 129-148.
Lampugnani A. (1652), Lumi della lingua italiana, Diffusi da Regole abbreviate, e Dubbi esaminati, Per lo fuggitivo Academ. Indomito, Bologna, per Carlo Zenero.
LEXICON GRAMMATICORUM = Lexicon Grammaticorum. Who’s Who in the History of World Linguistics (1996), Stammerjohann H. (ed.), Tübingen, M. Niemeyer, Tübingen.
Manni P., Tomasin L. (2016), “Storia linguistica interna: profilo dei volgari italiani”, in. Lubello S. (a cura di), Manuale di linguistica italiana, De Gruyter, Berlin-Boston, pp. 31-61.
Maraschio N. (2008), Il secondo Cinquecento, in Mortara Garavelli B. (a cura di), Storia della punteggiatura in Europa, Laterza, Roma-Bari, pp. 122-137.
Marazzini C. (1993), Storia della lingua italiana. Il secondo Cinquecento e il Seicento, il Mulino, Bologna.
Marazzini C. (2008), Il Seicento, in Mortara Garavelli B. (a cura di), Storia della punteggiatura in Europa, Laterza, Roma-Bari, pp. 138-158.
Masini A. (1977), La lingua di alcuni giornali milanesi del 1859 al 1865, La Nuova Italia, Firenze.
Mattarucco G. (2001), “Alcuni punti critici nelle grammatiche italiane da Fortunio e Buonmattei”, in Studi di Grammatica Italiana, XIX, pp. 93-139.
Migliorini B. (1956), “Panorama dell’italiano secentesco”, in Rassegna della Letteratura Italiana, LX, pp. 1-50.
Migliorini B. (1960), Storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze.
Migliorini B. (2019), Storia della lingua italiana, Bompiani, Milano.
Mortara Garavelli B. (a cura di) (2008), Storia della punteggiatura in Europa, Laterza, Roma-Bari.
Nencioni G. (1974), Presentazione della ristampa anastatica dell’ed. 1881 di R. Fornaciari, Sintassi italiana dell’uso moderno, Sansoni, Firenze, pp. III-XXVII.
OPAC SBN = Catalogo collettivo delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale (Online Public Access Catalogue: https://opac.sbn.it/).
Padley G. A. (1988), Grammatical Theory in Western Europe (1500-1700). Trends in Vernacular Grammar, Cambridge University Press, Cambridge.
Pallavicino Sforza (1661), Avvertimenti gramaticali per chi scrive in lingua italiana, dati in luce dal p. Francesco Rainaldi, in Roma, presso il Varese.
Patota G. (1993), I percorsi grammaticali, in Serianni L., Trifone P. (a cura di), Storia della lingua italiana. Vol I. I luoghi della codificazione, Einaudi, Torino, pp. 93-137.
Patota G. (2007), Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, il Mulino, Bologna.
Patota G. (2017), La quarta corona. Petro Bembo e la codificazione dell’italiano scritto, il Mulino, Bologna.
Pergamini G. (1613), Trattato della lingua del signor Giacomo Pergamini da Fossombrone. Nel quale con una piena, e distinta Instruttione si dichiarano tutte le Regole, & i Fondamenti della Fauella Italiana, In Venezia, Per Bernardo Giunta, Gio. Battista Ciotti.
Poggiogalli D. (1999), La sintassi nelle grammatiche del Cinquecento, Accademia della Crusca, Firenze.
Prada M. (2012-2013), “Le avventure di una lingua: il viaggio alla scoperta dell’italiano nella Grammatica di Giannettino”, in Studi di grammatica italiana, Vol. XXXI-XXXII, pp. 245-353.
Robustelli C. (2006), Grammatici italiani del Cinque e del Seicento: vie d’accesso ai testi, Mucchi, Modena.
Rovito P. (1991), “De Pietri, Francesco”, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 39: https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-pietri_(Dizionario-Biografico)/.
Rohlfs G. (1966-1969), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., Einaudi, Torino.
Segre (1976), “La lingua del Seicento”, in Caretti L., Luti G. (a cura di), La letteratura italiana: per saggi storicamente disposti, Il Seicento, vol. IV, Mursia, Milano, pp. 209-212.
Stoppelli P. (a cura di) (2008), Filologia dei testi a stampa, Nuova edizione aggiornata, CUEC/Centro di Studi Filologici Sardi, Cagliari.
Trabalza C. (1963), Storia della grammatica italiana, Arnaldo Forni Editore, Bologna.
Trissino G. G. (1529), La grammatichetta di M. Giovan Giorgio Trissino, Vicenza, presso Tolomeo Ianiculo da Bressa.
Vallance L. (2009), “Uh che bel caso! Il grammatico dimezzato”, in Vox Romantica, 1, pp. 44-97.
Vallance L. (2019), Le Grammairiens Italiens face à leur langue (XVe -XVe s.), De Gruyter, Berlin.
Villari S. (2016), Che cos’è la filologia dei testi a stampa, Carocci, Roma.
Vitale M. (1984), La questione della lingua, Palumbo, Palermo.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Viviana de Leo

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.