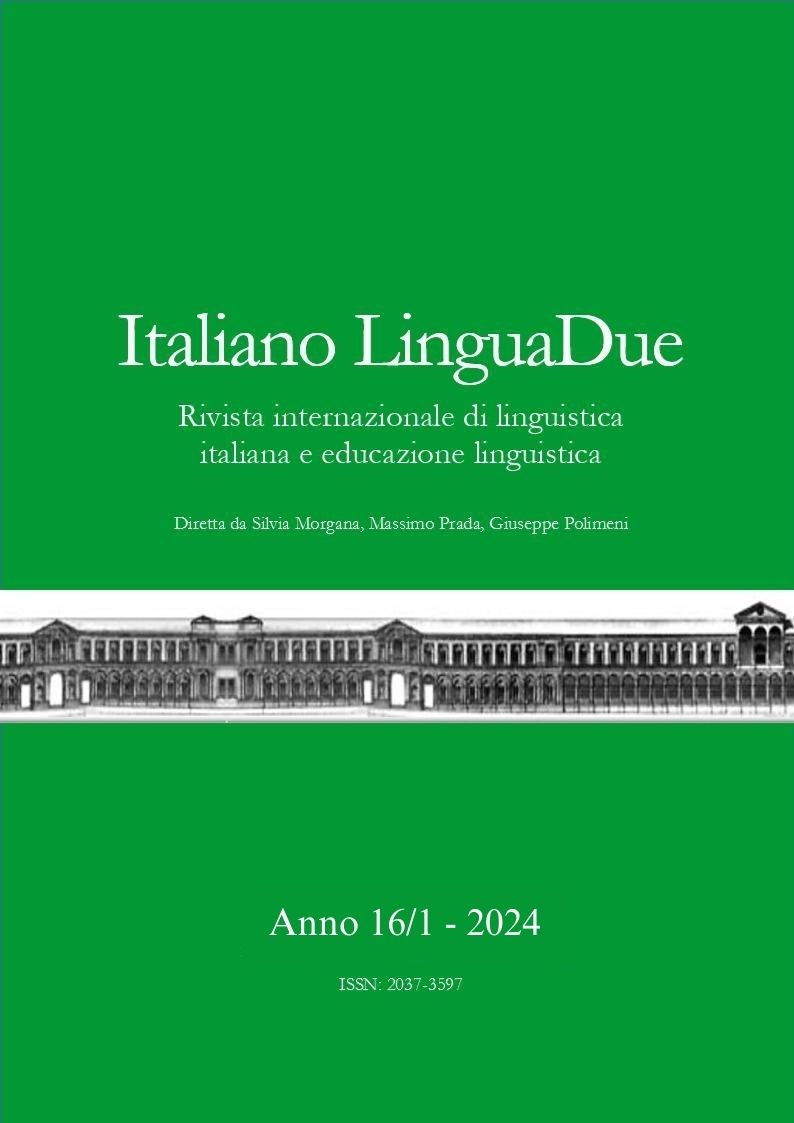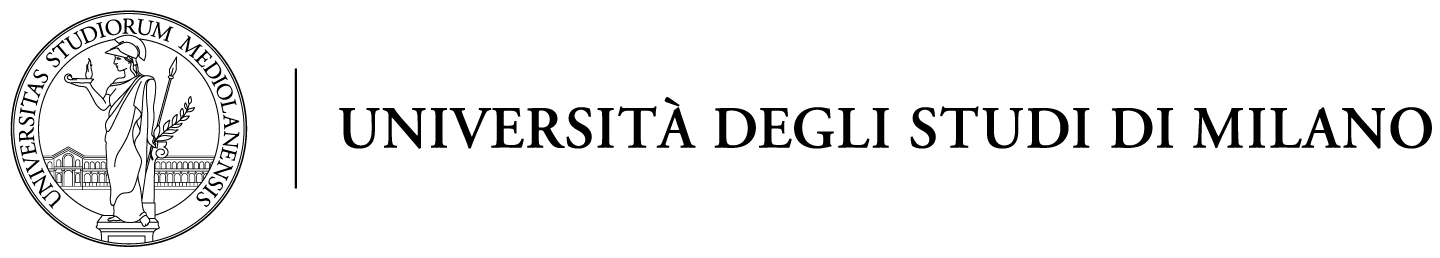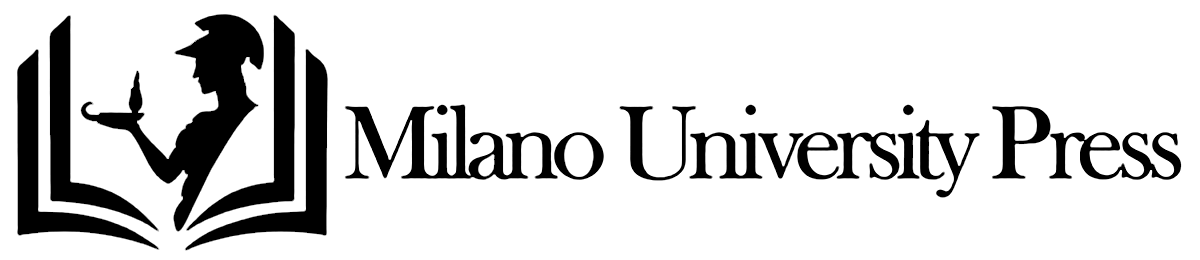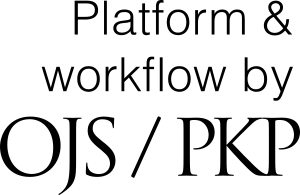LE METAMORFOSI DA DESCO. PRIMI SONDAGGI SULLA LINGUA DELL’ORDINE DE LE IMBANDISONE (1489)
DOI:
https://doi.org/10.54103/2037-3597/23889Abstract
Nell’Italia delle corti, dove le occasioni di banchetto costituiscono la più alta espressione del benessere economico e della potenza politica dei signori, le feste nunziali sono pensate come momenti conviviali e celebrativi, ma al contempo sono volute per rinnovare equilibri interni in funzione della pace sociale. Frequenti in queste occasioni sono le rappresentazioni sceniche, durante le quali gli invitati assistono a un vero e proprio spettacolo, accompagnato solitamente da letture, mimi e musica; in genere la messa in scena è sostenuta da un testo, spesso opera di un poeta di corte. L’articolo offre una prima indagine, storica e linguistica, dell’Ordine de le imbandisone, “poemetto” in versi di patina settentrionale, pensato per accompagnare la festa di nozze organizzata a Tortona, il 25 gennaio 1489, in occasione del matrimonio di Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza. L’analisi sulla lingua, che si anticipa in questa sede e che verrà poi ampliata in uno studio successivo, permette di riflettere sulla «policromia espressiva» del poemetto, che da un lato prende forma nell’impiego di una lingua illustre e nel recupero di tessere dantesche e petrarchesche, dall’altro si profila nella selezione di tratti lombardi e latamente settentrionali, che a quest’altezza cronologica sono testimonianza della volontà di dichiarare un’appartenenza, preservando gli elementi locali, distintivi e identitari, depurate le forme più esplicitamente municipali.
Metamorphosis at the banquet. First linguistic reflections on the Ordine de le imbandisone (1489)
In the Italy of the courts, where banqueting occasions constitute the highest expression of the economic well-being and political power of the lords, nuptial feasts are thought of as convivial and celebratory moments, but at the same time they are desired to renew internal balances in function of social peace. Frequent on these occasions are stage performances, during which guests witness a real show, usually accompanied by readings, mimes and music; usually the staging is supported by a text, often the work of a court poet. The article offers an initial survey, both historical and linguistic, of the Ordine de le imbandisone, a “poem” in verse with a northern patina, designed to accompany the wedding feast organized in Tortona on January 25, 1489, for the marriage of Isabella of Aragon and Gian Galeazzo Sforza. The analysis on the language, which is anticipated here and will be expanded in a later study, allows us to reflect on the “expressive polychromy” of the poem, which on the one hand takes shape in the use of an illustrious language and in the recovery of Dantean and Petrarchan tesserae, and on the other is profiled in the selection of Lombard and languidly northern features, which at this chronological height are evidence of the desire to declare a belonging, preserving local, distinctive and identity-based elements, purified of more explicitly municipal forms.
Downloads
Riferimenti bibliografici
Albonico S. (1990), Il ruginoso stile: poeti e poesia in volgare a Milano nella prima metà del Cinquecento, FrancoAngeli, Milano.
Albonico S. (1995), “Appunti su Ludovico il Moro e le lettere”, in Giordano L. (a cura di), Ludovicus Dux, Diakronia, Vigevano, pp. 66-92.
Albonico S., Moro S. (2020), Gaspare Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, Viella, Roma.
Albonico S. (2020), “Appunti sul «De Paulo e Daria amanti»”, in Albonico S., Moro S. (a cura di), Gaspare Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, Viella, Roma, pp. 267-90.
Angiolillo M. (1979), Leonardo: feste e teatri, Società Editrice Napoletana, Napoli.
Anselmi G. M., Guerra M. (2006), Le Metamorfosi di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Gedit, Bologna.
Aresti A. (2021), Il glossario latino-bergamasco (sec. XV) della Biblioteca Universitaria di Padova (ms. 534) : nuova edizione con commento linguistico, note lessicali e indici delle voci, De Gruyter, Berlin.
Bárberi Squarotti G. (1990), Storia della civiltà letteraria, II. Umanesimo e Rinascimento, UTET, Torino.
Beccaria G.L., Stella A., Vignuzzi U. (2005), La linguistica in cucina: i nomi dei piatti tipici, Edizioni Unicopli, Milano.
Bellonci M., Dell’acqua G.A, Perogalli C. (a cura di) (1977), I Visconti a Milano, Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Milano.
Benporat C. (1996), Cucina italiana del Quattrocento, Olschki, Firenze.
Benporat C. (2001), Feste e banchetti. Convivialità italiana fra Tre e Quattrocento, Olschki, Firenze.
Bertolini B. (1998), “Fra pratica e scrittura: la cucina nell’Europa del tardo Medioevo”, in Archivio storico italiano, CLVI, 4, pp. 737-743.
Biancardi G. (1993), “La «Coronatione» di Bianca Maria Sforza. Un poemetto in ottave di Baldassarre Taccone”, in Studi e fonti di Storia lombarda. Quaderni milanesi, 13, pp. 43-121.
Bolgar R. R. (1954), The Classical Heritage and its beneficiaries: from the carolingian age to the end of the Renaissance, Cambrige University Press.
Bongrani P. (1986), Lingua e letteratura a Milano nell’età sforzesca: una raccolta di studi, Università degli Studi-Istituto di Filologia moderna, Parma.
Bongrani P., Morgana S. (1992), “La Lombardia”, in Bruni F. (a cura di), L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali, UTET, Torino.
Bosisio M. (2018-19), “«L’acqua del Parnaso». Bernardo Bellincioni e la corte di Ludovico il Moro”, in Testi & Documenti, XLIV-XLV, pp. 71-92.
Bosisio M. (a cura di) (2019), Il teatro delle corti padane (1478-1508), introduzione di Bentoglio A., Edizioni Unicopli, Milano.
Calco T. (1644), “Nuptiae Mediolanensium Ducum sive Joannis Galeaci cum Isabella Aragona”, in Puricelli G. P. (a cura di), Tristani Chalci Mediolanensi Historiographi Residua, Fratelli Malatesta, Milano.
Casini Ropa E. (1983), “Il banchetto di Bergonzio Botta per le nozze di Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza nel 1489: quando la storiografia si sostituisce alla storia”, in Spettacoli conviviali dall’antichità classica alle corti italiane del ’400, Atti del VII convegno di Studio del Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale (Viterbo, 27-30 maggio 1982), Union Printing, Viterbo, pp. 291-306.
Cognasso F. (1955), “Il ducato visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria”, in Storia di Milano, VI, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano.
Covini M. N. (2024), Ludovico Maria Sforza. La scalata al potere del ‘Moro’ e gli splendori del corte milanese a fine Quattrocento, Salerno, Roma.
Cougnet A. (1903), I piaceri della tavola, Bocca, Torino.
De Rénoche E. (1902), “Le favole mitologiche della fine del sec. XV”, in Giornale storico e letterario della Liguria, 3, pp. 161-190.
Diadori P., Frosini G. (a cura di) (2023), La cucina italiana fra lingua, cultura e didattica, Franco Cesati Editore, Firenze.
Ferrorelli N. (1914), “Il ducato di Bari sotto Sforza Maria Sforza e Ludovico il Moro”, in Archivio Storico Lombardo, 5, Fasc. 3, pp. 389-468.
Finzi C. (1991), “Il principe e l’obbedienza. I primi scritti politici di Giovanni Pontano”, in Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Publications de l’École Française de Rome, n. 147, pp. 263-279.
Finzi C. (2014), “Giovanni Pontano”, in Enciclopedia machiavelliana, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
Formentin V. (1996), “La “crisi” linguistica del Quattrocento”, in Storia della letteratura italiana, III. Il Quattrocento, Salerno, Roma, pp. 159-210.
Frosini G. (1993), Il cibo e i signori. La mensa dei priori di Firenze nel quinto decennio del sec. XIV, Accademia della Crusca, Firenze.
Frosini G., Robustelli C. (2009), “Premessa”, in Storia della lingua e storia della cucina. Parola e cibo: due linguaggi per la storia della società italiana, Atti del VI Convegno ASLI Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Modena, 20-22 settembre 2007), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. XIII-XVI.
Frosini G., Lubello S. (a cura di) (2023), L’italiano del cibo, Carocci, Roma.
Ganda A. (1984), I primordi della tipografia milanese. Antonio Zarotto da Parma (1471-1507), Olschki, Firenze.
Grafton A., Most G. W., Settis S. (2010), “Ovid”, in ID (eds.), The Classical Tradition, Harvard University Press, Cambridge, pp. 143-159.
Hare C. (1911), Isabella of Milan princess d’Aragona and wife of Duke Gian Galeazzo Sforza the intimate story of the life in Milan told in the letters of her ladi in waiting, Harper, London.
Highet G. (1949), The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Tradition, Oxford University Press, Oxford.
Kallendorf C.W. (2010), A Companion to the Classical Tradition, Wiley-Blackwell, Chichester.
Lubello S. (2002), “I ricettari di cucina italiani dei secoli XIV-XVI”, in Saperi e sapori mediterranei. La cultura dell’alimentazione e i suoi riflessi linguistici (Napoli, 13-16 ottobre 1999, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), Torcoliere, Napoli, pp. 1141-1153.
Lubello S. (2024), Minima culinaria. Storie di parole, incontri di culture, Edizioni dell’Orso, Alessandria.
Montagnani C. (2021), “«A’ fianchi hanno gli sproni / e poeti a Ferrara»: esperimenti teatrali alla corte di Ludovico il Moro”, in Baldassari G., Barucci G., Carapezza S., Comelli M. (a cura di), Rinascimenti in transito a Milano (1450-1525), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, LEDI, Milano, pp. 217-228.
Morgana S. (1995), “Lingue e varietà di lingua nella Milano sforzesca”, in Incontro di studio n. 4, Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano, pp. 7-17.
Morgana S. (2012), Storia linguistica di Milano, Carocci, Roma.
Morgana S. (a cura di) (2022), La letteratura dialettale milanese. Autori e testi, 2 Voll., Salerno, Roma.
Moro S. (2020), “Il rapporto tra la corte sforzesca e i poeti milanesi allo specchio della tradizione bucolica. Il caso di Gaspare Ambrogio Visconti”, in Campana A., Giunta F. (a cura di), Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018), Adi editore, Roma, pp. 1-12: https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/natura-societa-letteratura/02_Moro.pdf.
Moro S. (2021), “Un’accademia milanese di fine Quattrocento. Incontri tra letterati e dinamiche culturali all’ombra della domus di Gaspare Ambrogio Visconti”, in Baldassari G., Barucci G., Carapezza S., Comelli M. (a cura di), Rinascimenti in transito a Milano (1450-1525), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, LEDI, Milano, pp. 137-186.
Paratore E. (1970), “Publio Ovidio Nasone”, in Enciclopedia Dantesca, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
Passera C. (2017), “Un incunabolo per lo sposalizio di Isabella d’Aragona: le Nuptiae Illustrissimi Ducis Mediolani di Stefano Dolcino (1489)”, in Drammaturgia, 14, 4, pp. 305-326.
Passera C. (2020), «In questo picolo libretto». Descrizioni di feste e di spettacoli per le nozze dei signori italiani del Rinascimento, Firenze University Press, Firenze.
Pepe L. (1900), Storia della successione degli Sforzeschi negli Stati di Puglia e di Calabria, Vecchi, Bari.
Pesenti Villa M. (1923), “I letterati e i poeti”, in Malaguzzi Valeri F., La corte di Ludovico il Moro, Le arti industriali, la letteratura, la musica, IV, Hoepli, Milano, pp. 105-181.
Petrucci F. (1973), “Tristano Calco”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 16.
Pirrotta N. (1975), Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Einaudi, Torino.
Pontano G. (1965), I trattati: De liberalitate, De beneficentia, De magnificentia, De splendore, De conviventia, Introduzione, testo, traduzione e note a cura di Francesco Tateo, Edizioni dell’Ateneo, Roma.
Pregnolato S. (2019), “Il «più antico» ricettaio culinario italiano nel codice Riccardiano 1071. Appunti preliminari, nuova edizione del testo e Indice lessicale”, in Tra filologia, erudizione e linguistica. Per Giuseppe Frasso, cinque giovani allievi, StEFI. Studi di Erudizione e di Filologia Italiana, 8, pp. 219-324.
Pyle C. M. (1991), “Per la biografia di Baldassare Taccone”, in Archivio storico lombardo, 117, pp. 391-413.
Pyle C. M. (1993a), “Per un’iconologia dello spettacolo: dalle nozze sforzesche del 1489 alle favole mitologiche”, in Arte Lombarda, 105/107, 2-4, pp. 84-87.
Pyle C. M. (1993b), “Una relazione sconosciuta delle nozze di Isabella d’Aragona con Giangaleazzo Sforza nel febbraio 1489: Giovanni II Tolentino a Baldassare Taccone”, in Libri e documenti, XVIII, pp. 20-26.
Pyle C. M. (1997), Milan and Lombardy in the Renaissance: essays in Cultural History, La Fenice, Roma.
Pyle C. M. (2019), “Baldassarre Taccone”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 94.
Quondam A. (2004), “Pontano e le moderne virtù del dispendio onorato”, in Quaderni Storici, 39, 115, 1, pp. 11-43.
Repishti F. (2020), “Baldassare taccone e le statue di Ludovico Maria e Massimiliano Sforza per la Madonna di Galliera a Bologna”, in Arte Lombarda, 188, 1, pp. 119-121.
Ricotta V. (2023a), “Lingua e cucina. Parole e cibo tra Medioevo e Rinascimento”, in Burgassi C., Guadagnini E., Vaccaro G. (a cura di), Storia di idee nell’Europa mediterranea. Trasmissione di parole e saperi nel Medioevo e nella prima età moderna, ISEM, Bulzoni, Roma.
Ricotta V. (2023b), I Banchetti, compositioni di vivande et apparecchio generale di Cristoforo Messi Sbugo. Edizione e studio linguistico, Olschki, Firenze.
Rogledi Manni T. (1980), La tipografia a Milano nel XV secolo, Olschki, Firenze.
Rossetti E. (2020), “Gaspare Ambrogio Visconti”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 99.
Rossi L. (1972), Storia del balletto, Cappelli, Bologna.
Rozzo U. (1971), “Giacomo Botta”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 13.
Rozzo U. (1989a), “La festa di nozze sforzesca del gennaio 1489 a Tortona”, in Libri & Documenti, XV, 1, pp. 1-23.
Rozzo U. (1989b), “L’Ordine de le imbandisone per le nozze di Gian Galeazzo Sforza con Isabella d’Aragona”, in Libri & Documenti, XIV, pp. 1-14.
Sada L. (1988), Il banchetto nuziale di Isabella d’Aragona Duchessa di Milano e di Bari a Tortona nel 1485, Edizioni del Centro librario, Bari-Santo Spirito.
Santoro C. (1977), Gli Sforza, Dall’Oglio, Milano.
Serianni L. (2009), La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Carocci, Roma.
Stella A., Repossi C., Pusterla F. (1990), Lombardia, La Scuola, Brescia.
Stella A. (1994), “Lombardia”, in Serianni L., Trifone P. (a cura di), Le altre lingue. Storia della lingua italiana, Einaudi, Torino, pp. 153-212.
Stella A. (2005), “«Povere cene» di Lombardia”, in Beccaria G. L., Stella A., Vignuzzi U. (a cura di.), La linguistica in cucina: i nomi dei piatti tipici, Edizioni Unicopli, Milano, pp. 25-101.
Tani U. (1954), “Bergonzio Botta”, in Enciclopedia dello Spettacolo, II, Le Maschere, Roma.
Tavoni M. (1992), Il Quattrocento, il Mulino, Bologna.
Tissoni Benvenuti A. (1983), “Il teatro volgare della Milano sforzesca”, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno Internazionale (28 febbraio-4 marzo 1983), Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, pp. 333-351.
Tissoni Benvenuti A. (1983), Narrativa e teatro, in Teatro del Quattrocento: le Corti Padane, UTET, Torino, pp. 419-470.
Tissoni Benvenuti A. (2017), “Genere bucolico poesia pastorale. Le metamorfosi dell’egloga nel Quattrocento”, in Italique. Poésie italienne de la Reinassance, XX, pp. 14-31.
Vaglienti F. M. (2010), “«Governare, io donna». Isabella d’Aragona principessa delle due Italie”, in Mainoni P. (a cura di), «Con animo virile», Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XIXV), Viella, Roma, pp. 455-484.
Ventrone P. (2013a), “Modelli ideologici e culturali nel teatro milanese di età viscontea e sforzesca”, in Bellini E., Rovetta A. (a cura di), Prima di Carlo Borromeo. Lettere e arti a Milano nel primo Cinquecento, Bulzoni, Roma, pp. 247-282.
Ventrone P. (2013b), “Simbologia e funzione delle feste identitarie in alcune città italiane fra XIII e XV secolo”, in Teatro e Storia, XXVII, 34, pp. 285-310.
Ventrone P. (2012), “La costruzione dell’identità cittadina in Italia tra XIII e XV secolo: feste, rituali, simboli”, in Sabatè F. (a cura di), Identitats, Atti del XIV Curs d’estiu – Reunió científica Comtat d’Urgell (Balaguer, 1-3 luglio 2009), Pagès editors, Lleida, pp. 225-254.
Ventrone P. (2013a), “Modelli ideologici e culturali nel teatro milanese di età viscontea e sforzesca”, in Bellini E., Rovetta A. (a cura di), Prima di Carlo Borromeo. Lettere e arti a Milano nel primo Cinquecento, Bulzoni, Roma, pp. 247-282.
Ventrone P. (2013b), “Simbologia e funzione delle feste identitarie in alcune città italiane fra XIII e XV secolo”, in Teatro e Storia, XXVII, 34, pp. 285-310.
Ventura E. (2020), La «Chirurgia Magna» di Bruno da Longobucco in volgare, De Gruyter, Berlin.
Vianello C.A. (1941), Teatri, spettacoli, musica a Milano nei secoli scorsi, Libreria Lombarda, Milano.
Vitale M. (1953), La lingua volgare della Cancelleria Visconteo-Sforzesca nel Quattrocento, con una premessa di Antonio Viscardi, Cisalpino, Varese-Milano.
Vitale M. (1992), “Il dialetto ingrediente intenzionale della poesia non toscana del secondo Quattrocento”, in Id., Studi di storia della lingua italiana, LED, Milano, pp. 49-94 (da cui si cita); già in Rivista Italiana di Dialettologia, X, 1986, pp. 7-44.
Vitale M. (1983), “La lingua volgare della cancelleria sforzesca nell’età di Ludovico il Moro”, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, Comune di Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, 2 voll., Vol. II, pp. 353-386; oggi in ID., La veneranda favella. Studi di storia della lingua italiana, Morano, Napoli, 1988, pp. 169-239.
Walde C. (2010), “Ovidio”, in Der Neue Pauly. Supplemente, 7, “Die Rezeption der antiken Literatur”, Stuttgart-Weimar, pp. 557-608.
Zapperi R. (1971), “Bergonzio Botta”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 13.
Dowloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Elena Felicani

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.